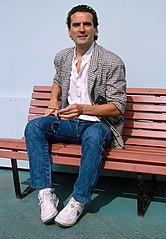Se Maradona fosse nato a San Giorgio a Cremano, sarebbe stato il Massimo Troisi del calcio: sarebbe stato ancor di più un eroe campano, appartenendo a quei colori per nascita, e il suo modo di giocare non sarebbe stato meno acclamato. Non avremmo detto di lui che era l’espressione del calcio partenopeo, ma semplicemente che era l’espressione del calcio. Allo stesso modo, si dice che Troisi abbia raccontato la Napoli degli anni Ottanta, ed è vero. Ma in realtà non ha raccontato soltanto Napoli, e non soltanto la sua generazione. Massimo Troisi è partito da Napoli – senza tradirla mai – in un momento difficile e forse di svolta nella sua storia, e ha esportato nel resto d’Italia qualcosa che non era ancora mai stata in scena, da cui in tantissimi si sono sentiti rappresentati. La sua è stata un’innovazione soprattutto culturale. Ha mostrato un protagonista napoletano diverso dagli stereotipi che avevano spopolato fino a quel momento: timido ma comunque arguto, spesso impaziente ma anche sopraffatto dagli eventi e incapace di prendere decisioni, attraversato da mille dubbi, gli stessi che abbiamo ancora oggi.
La sua forza è stata quella di non cercare il difficile, l’anomalo o l’esagerato, ma quella di portare sul grande schermo il normale, una quotidianità sobria e tutta da approfondire. Perché i personaggi che nei suoi lavori gli ruotano intorno sono individuabili anche in altre realtà dell’epoca – ad esempio nel cinema di Nanni Moretti – ma lui è come se non fosse un attore all’interno del film. In quei momenti diventa tutti noi che lo guardiamo. Tutti noi che balbettiamo durante un discorso importante o che interrompiamo bruscamente una frase per aprirne un’altra. Tutti noi che sembriamo in difficoltà nel trovare le parole giuste e le andiamo a cercare con gli occhi e con le mani. Negli anni Ottanta era opinione comune che il suo cinema raccontasse la realtà dei giovani campani meglio di tanti documentari. Avrebbe potuto parlare torinese, umbro o calabrese, il suo messaggio sarebbe arrivato con la stessa intensità, perché quei sentimenti che ha portato in scena erano – e sono – condivisi da tantissimi ragazzi italiani.
Massimo Troisi ha creato un bellissimo cortocircuito e continua a crearlo ogni volta che lo vediamo perché la sua non sembra recitazione. Quel linguaggio dinamico, frammentato da pause e balbettii è spontaneo, è il nostro, è di chi tutti i giorni si trova a discutere con gli amici, con i colleghi o con il proprio partner. È un linguaggio di silenzi e di gesti, di espressioni inconfondibili e di riflessioni ingombranti sul senso della vita. E pure le tematiche che affronta sono d’attualità da quarant’anni: l’amore, il lavoro e la loro mancanza, l’incomunicabilità dei sentimenti, le difficoltà nell’emancipazione e nella realizzazione personale. Troisi è universale, siamo tutti un po’ Troisi.
Ha anche rivoluzionato la percezione di Napoli nella cultura di massa, scardinando i luoghi comuni con sagacia.