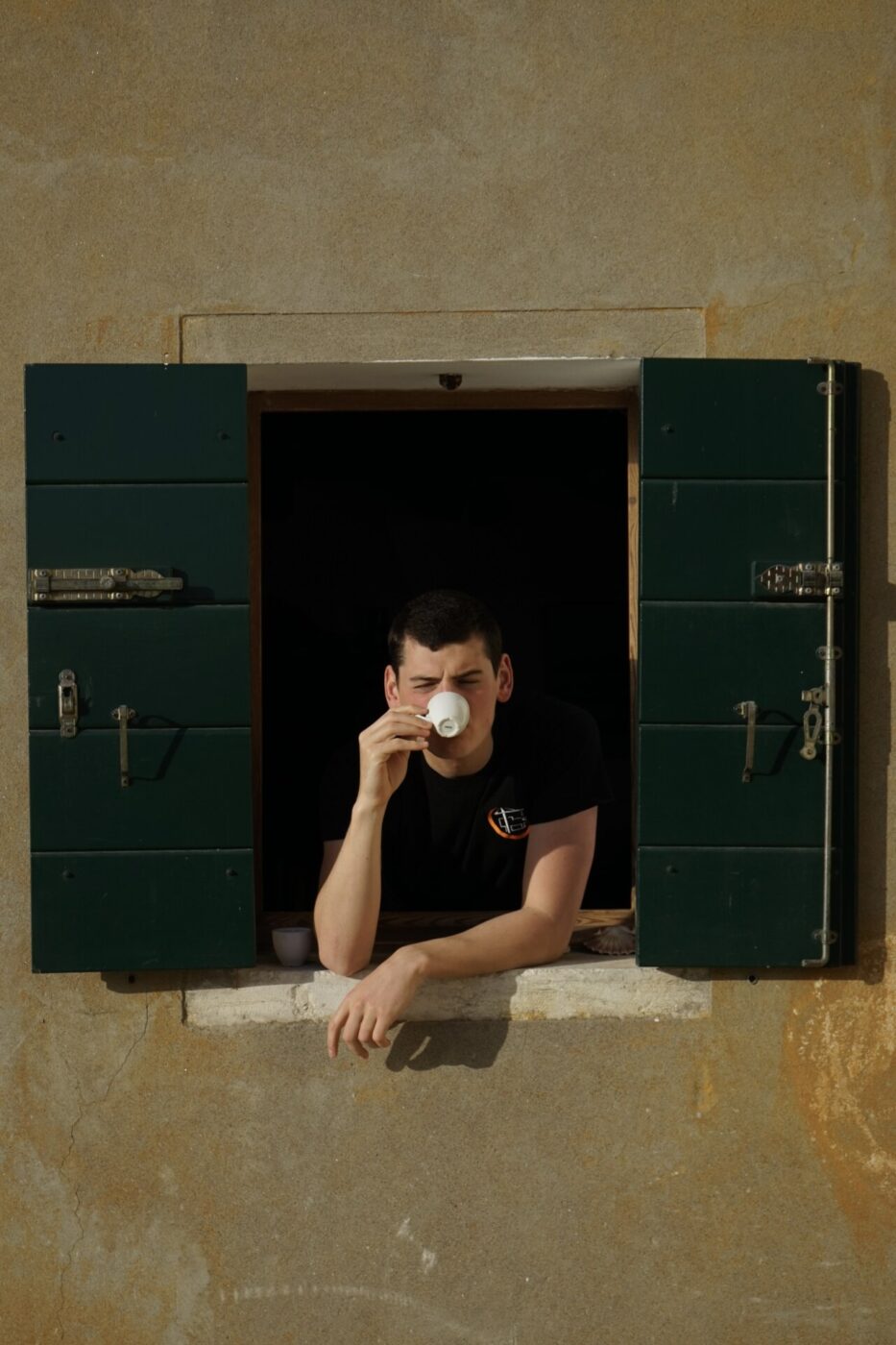Pellestrina è una striscia di terra sottile e allungata, per l’esattezza lunga undici chilometri, posta tra la Laguna di Venezia e il Mare Adriatico. La sua larghezza varia da un minimo di ventitré metri ad un massimo di 1,2 km, che è anche la distanza tra l’acqua salata e quella salmastra. Sul lato della laguna, una collana di piccole case colorate – barche ormeggiate di fronte – ciascuna dipinta con un colore brillante, distinto da quelle accanto. Per qualche ragione, il risultato non è il tipico look muranese già visto su Instagram. La semplicità è al centro dello spirito di Pellestrina: è un luogo costruito per essere abitato. Al centro dell’isola, a separare la laguna dal mare, c’è un lungo muro conosciuto come “la diga”. Dall’altro lato, quello del mare, da una punta all’altra si estende una spiaggia sabbiosa e selvaggia. Le uniche strutture che offrono ombra sono i capanni, piccole tettoie costruite dagli isolani con tutto ciò che il mare ha portato a riva durante l’inverno. A parte una fila di arbusti lungo il muro, c’è poca o nessuna vegetazione. L’estate è calda e umida, l’aria pesante; le notti sono benedette da una leggera brezza e gli isolani si incontrano ogni giorno sulla riva della laguna. Qualcuno potrebbe sentirsi fortunato e provare a pescare; la maggior parte trascorre il tempo chiacchierando lentamente della lentezza delle giornate.
Da bambina, era l’isola delle infinite passeggiate domenicali imposte dai genitori quella di cui mi lamentavo molto. Sia in bicicletta che a piedi, sembrava senza fine. Mi pareva così inutile camminare senza meta per ore solo per raggiungere una panchina all’estremità opposta, mangiare un panino e tornare indietro. Le mie forti rimostranze venivano sempre accolte con la stessa frase criptica e aforistica: “Su un’isola ci vai per essere isolato”.
Passarono gli anni e la mia famiglia, che vive nella regione, alla fine decise di acquistare una piccola casa, più o meno al centro dell’isola, di fronte alla laguna. “Un rifugio”, hanno detto. Da cosa avessero bisogno di rifugiarsi, io, undicenne, non ne ero sicura. In inverno, estate, primavera e autunno, partivano il venerdì per tornare il lunedì: sembravano rinvigoriti e sollevati. Difficile capire come un posto dall’aspetto così noioso potesse produrre un simile effetto. Ma dopo tutto, come scrisse una volta José Saramago, “Ogni isola è sconosciuta finché non ci metti piede”.
Passarono altri anni e cominciai a visitarla di tanto in tanto. C’era qualcosa di crudo e genuino in quel posto e nella sua gente che non riuscivo del tutto a cogliere. Portavo uno zaino pieno di libri, cercavo un angolo e mi perdevo in mondi immaginari. E il tempo cominciò ad acquisire più rilevanza; la sua misurazione era tutta un’altra cosa sull’isola. Con poco o nulla pianificato, poco o nulla da fare – con un solo bar/pizzeria, un minimarket e un’edicola tra cui scegliere per l’intrattenimento – le giornate dovevano essere completamente inventate. Erano pezzi di carta bianchi. L’organizzazione del tempo a cui ero abituata all’improvviso non è più servita a nulla, e questa costrizione all’astensione dalle attività “produttive” ha generato una curiosità e un desiderio di saperne di più, che si è trasformato in desiderio di sapere tutto. Ogni volta che andavo a Pellestrina volevo restare più a lungo e cominciavo a osservare, a fare domande.

UN’ISOLA DI PESCATORI
L’isola fu colonizzata per la prima volta – come tutte le isole veneziane – dopo le invasioni barbariche del VI secolo, da popolazioni locali in fuga dalla terraferma. Da allora la sua principale attività commerciale è stata la pesca. Pellestrina ha davvero la storia e l’anima di un’isola di pescatori. È il luogo del loro sapere, quel sapere che non può definirsi antico ed empirico e che non può che derivare da tradizioni di lunga data. Sull’isola non esiste il caso, la coincidenza o l’incidente. Prendi i colori delle case. I turisti, che raggiungono l’isola in massa durante i mesi estivi, scattano migliaia di foto delle costruzioni, tutte dipinte e molto instagrammabili. Ma la loro attrazione sui social media non è la ragione dietro le scelte cromatiche; la praticità lo è. Ogni casa era dipinta in modo da sembrare diversa in modo che i pescatori potessero distinguerla nella nebbia del primo mattino, mentre arrivavano a casa sani e salvi dopo la notte trascorsa a pescare e a provvedere alle proprie famiglie. Anche i camini sembrano particolari, con una struttura più grande del solito in cima. Solitamente costruiti in metallo, e spesso decorati con vernice o maiolica, sembrano scatole di ferro. Anche in questo caso non si tratta di una semplice scelta di stile: le dimensioni di questi camini proteggono quella che spesso è ancora l’unica fonte di calore domestico – il caminetto – dai forti venti che stagionalmente soffiano sull’isola.
L’isola è ricca anche dei cosiddetti capi saldi: cilindri di metallo arrugginito, di circa cinque centimetri di diametro, incastrati nei muri, storicamente utilizzati per l’orientamento geografico. Oggigiorno sono più punti di riferimento che preservano il nostro senso del luogo.

IL VENTRE DELLA “PACIFICITA’”
Durante l’estate – sempre più negli ultimi anni – Pellestrina è presa d’assalto da turisti in cerca della versione mercificata della pace dell’isola. La pandemia, con la mancanza di voli e l’impossibilità di raggiungere destinazioni di vacanza più lontane, ha accelerato il processo. D’inverno e nei mesi più freddi, invece, l’isola si svuota, lasciata ai suoi 4.000 residenti. La noia prende il sopravvento. Una vita segnata da questo contrasto può essere particolarmente critica per i giovani, e la maggior parte di loro decide di partire molto giovane. Chi sceglie di restare deve confrontarsi con le differenze della vita sull’isola rispetto alla terraferma o a Venezia: a Pellestrina non ci sono scuole superiori e, a partire dai quattordici anni, gli studenti devono recarsi a Venezia ogni mattina per continuare a studiare. Dopodiché, è solo questione di scelta. In un libro di memorie pubblicato di recente, “Battaglie di Neve: Memories of an Addict” (2022), Emanuele Ballarin, pellestrinese, racconta la storia fin troppo comune di tanti giovani cresciuti in Laguna: il duro contrasto tra la vita estiva e quella invernale, tra il movimento costante dell’uno e la quiete apparentemente infinita dell’altro, spesso porta i giovani a cercare altre forme di intrattenimento… e a trovarle nell’uso della droga. Non è raro, spiega Ballarin, che i ragazzi del posto sviluppino dipendenze fin dalla tenera età.
Il tasso di disoccupazione in costante aumento – oggigiorno attorno al 40% – non aiuta certamente. L’unica azienda rimasta oggi che lavora tutto l’anno, incurante dei ritmi fluttuanti del turismo, è un cantiere navale.
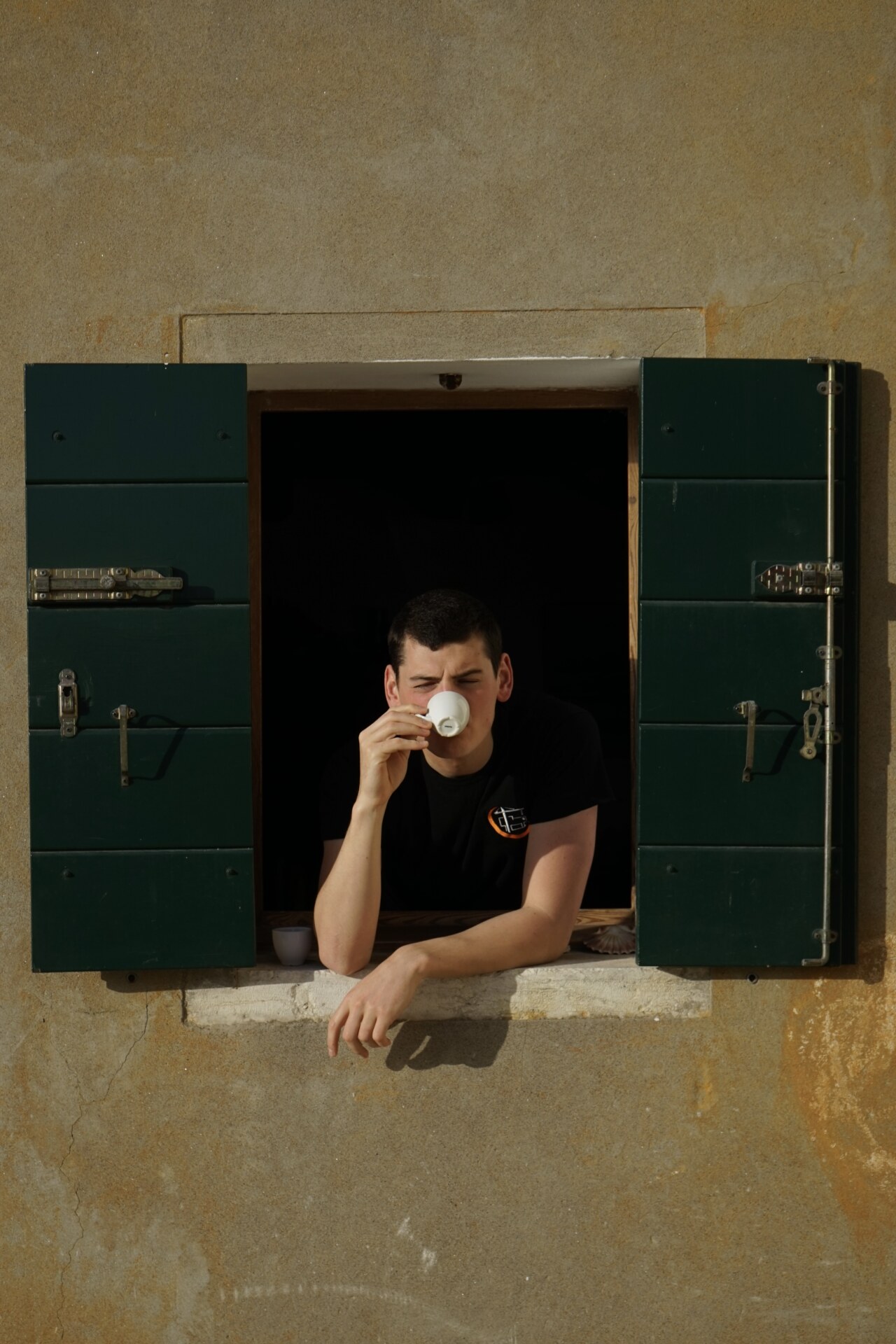
IL MOSE: PELLESTRINA SOPRA PER VENEZIA
La tradizione peschereccia dell’isola si è interrotta bruscamente con la realizzazione del progetto MOSE, iniziato nel 2003 e che dovrebbe concludersi il prossimo settembre: gigantesche dighe collocate in tutte le bocche di porto della laguna veneta, pensate per mitigare le devastanti effetti dell’Acqua Alta sulla città di Venezia. I pescatori sono stati incoraggiati a demolire le loro barche e a cessare tutte le attività, sebbene non siano state offerte loro fonti alternative di lavoro. Inoltre, il MOSE rischia di mettere a repentaglio la biodiversità locale. Il pesce è ormai sempre più difficile da reperire localmente, poiché lo scambio d’acqua tra mare e laguna, essenziale per preservare l’habitat, è ostacolato. E non è solo il pesce a rischiare di andare perduto, ma anche la tradizione culinaria locale.
Pellestrina, in particolare, corre un grosso rischio poiché la sua posizione costringe l’isola a fungere quasi da scudo per Venezia. L’Acqua Granda del 2019, quando l’acqua ha raggiunto quasi i due metri di altezza, è stata un perfetto esempio di questa vulnerabilità forzata. Nell’ambito del progetto MOSE è stato realizzato sul lato lagunare di Pellestrina un muro alto un metro; gli isolani avvisarono fin dall’inizio l’equipaggio che se l’acqua avesse oltrepassato il muro non sarebbe più potuta ritornare nella laguna. È successo esattamente questo e l’isola è rimasta sott’acqua per più di 24 ore.
“Siamo rimasti sul fondo del mare come vongole”, ha detto la gente del posto. Un articolo de La Repubblica la chiamava “la vergogna di Venezia”.
Ancora una volta, la competenza ingegneristica raramente tiene conto delle conoscenze locali che, in questo caso, avrebbero potuto evitare danni per 100.000 euro. Ma la questione della fragilità di Venezia è delicata: alcuni, come il celebre professor Luca Palmeri, sostengono che si debba scegliere tra salvare Venezia e le altre isole vicine. Altri, come il professor Luca Barausse, si imbarcano coraggiosamente in progetti locali di conservazione ambientale basati sulla natura per cercare percorsi alternativi che potrebbero salvare entrambi. A partire dal 2013 ha lanciato il progetto LIFE VIMINE, coinvolgendo i pescatori locali e le loro conoscenze ereditate per ridurre l’erosione dei Barens, isole galleggianti di vegetazione considerate il polmone della laguna. Questa unione di conoscenza locale e innovazione potrebbe essere proprio la chiave per immaginare un futuro diverso da questa fine apparentemente inevitabile.

Luoghi come Pellestrina – soprattutto perché vive all’ombra gloriosa, ma francamente ingombrante, di un patrimonio culturale immenso come Venezia – vanno protetti e curati. Alla loro esistenza è strettamente legato un lato umano vero, proprio, prezioso e raro. Abbiamo un dovere nei loro confronti. Uno di rispetto e attenta osservazione. Luoghi come questi potrebbero essere gli ultimi capisaldi per la possibilità di costruire qualcosa di diverso.
Una persona a cui voglio bene mi ha recentemente inviato un articolo di Giovanni Boine, uno scrittore italiano dei primi del ‘900. Nel pezzo, Boine si interroga su cosa significhi essere italiano (se davvero significa qualcosa) – o meglio sottolinea la mancanza di analisi sull’argomento da parte di coloro che incitano ciecamente a un vuoto nazionalismo. Certo, è difficile definire quali principi, sentimenti o valori siano alla base di una nazione, soprattutto di una nazione pluralistica come l’Italia. Eppure, in posti come Pellestrina, si respira un’ondata, una sensazione difficile da afferrare ma profondamente radicata, di come l’Italia respira, della vita italiana vissuta attraverso le cose semplici, dove spesso si trovano le verità più profonde.
Quello che so per certo è che, proprio come la prima popolazione in fuga dai barbari, proprio come i miei genitori in fuga dalle minacce barbariche della vita moderna, Pellestrina è diventata per me un rifugio, una fonte di insegnamenti e un modo per confrontarmi con me stessa, e con la vita, in modo diverso. Uno spazio da isolare, come ora ho capito, nel miglior modo possibile.
Sul traghetto per la terraferma prometto a me stessa che proverò a costruire i mondi immaginari di cui leggevo da bambina. E quindi eccomi tornata indietro. Ancora e ancora, rianimata e sollevata.