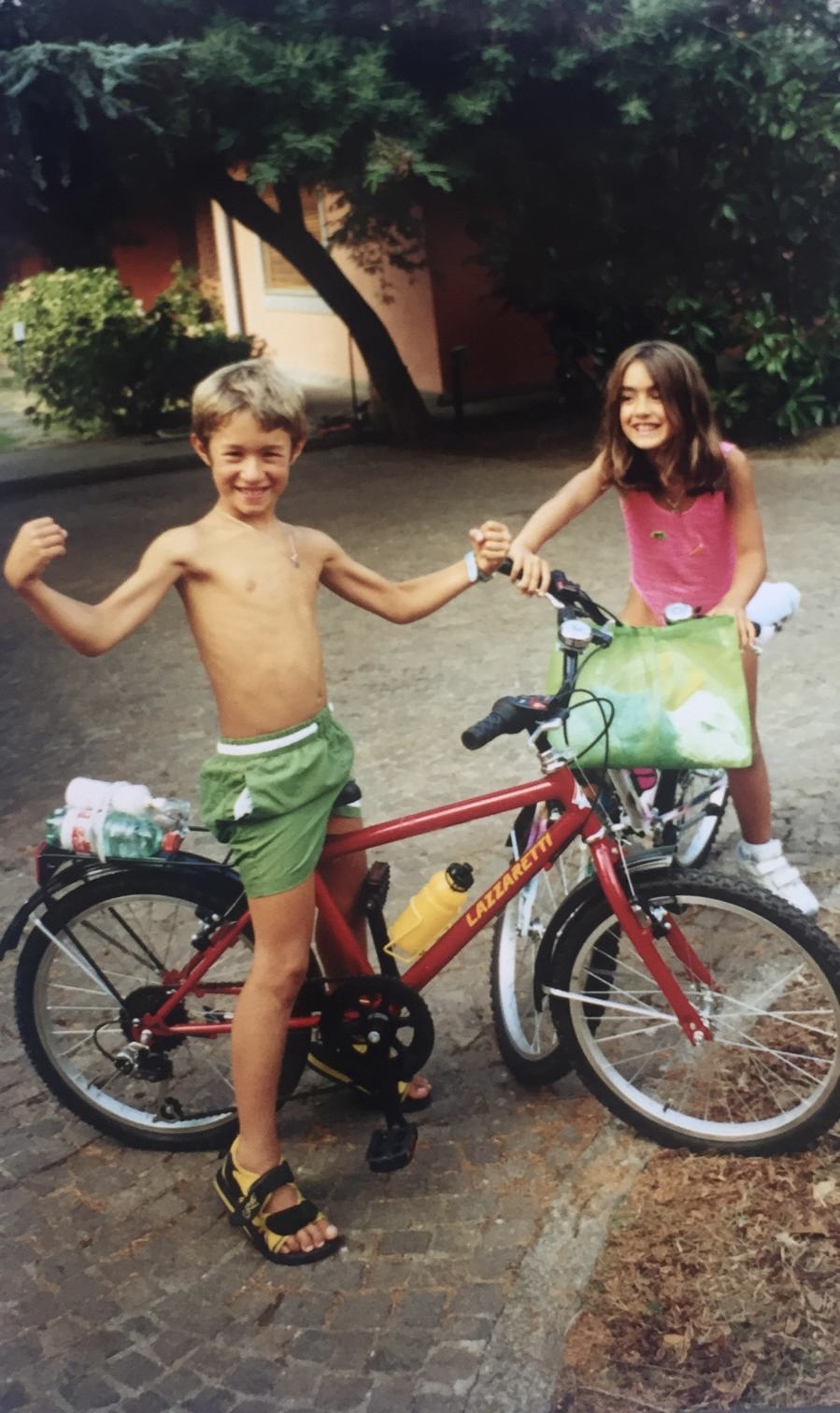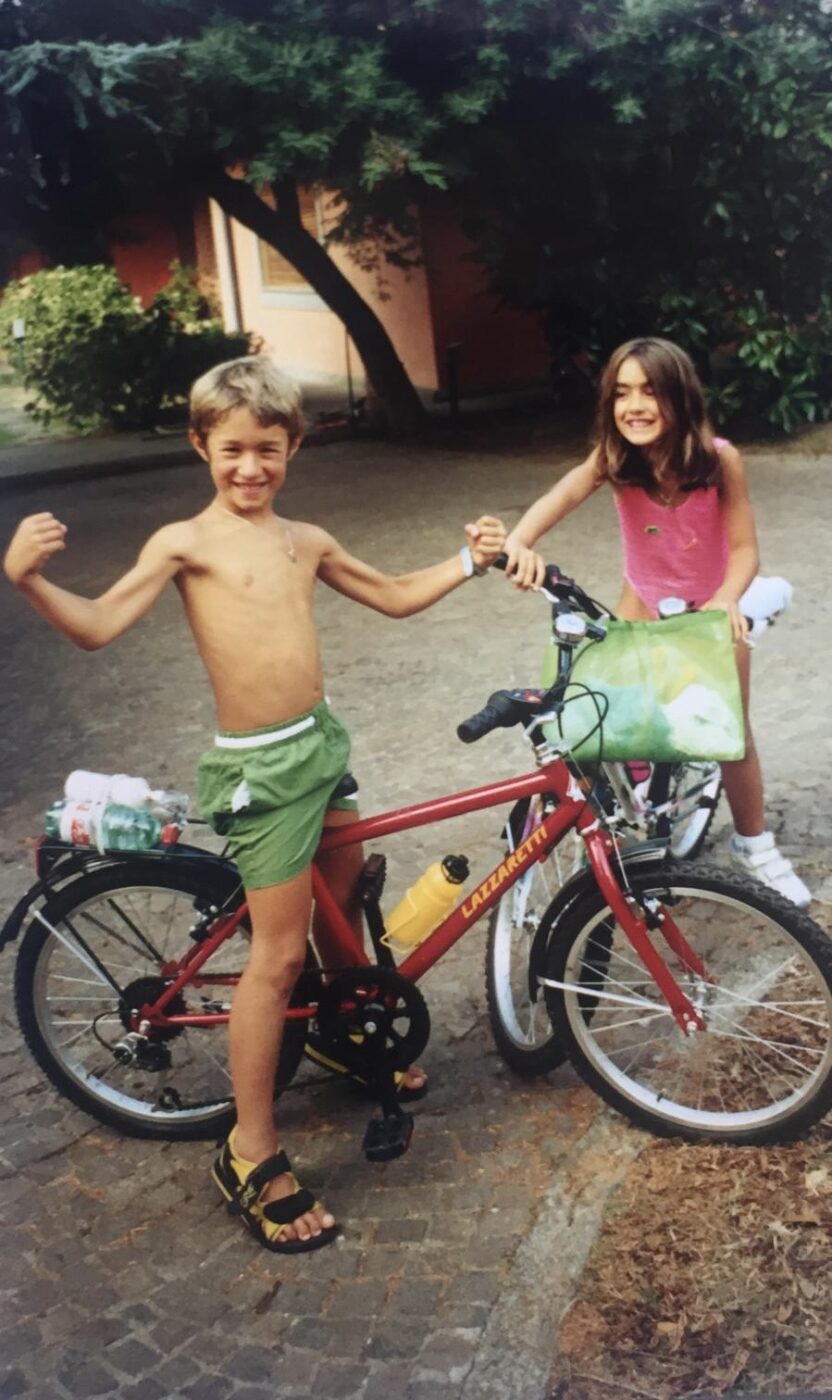Se questo fosse l’inizio di un film, la scena metterebbe in fila zie con trucco esagerato e cugini con le camicie aperte sul petto attorno a una tavola imbandita in modo stravagante. Sarebbe una delle prime, tra una forchettata di pasta e un sorso di vino, a fare la domanda inevitabile – “Quando farai dei figli?” – seguita da un silenzio imbarazzante interrotto solo dal tintinnio delle forchette. Certo, a volte succede così, ma più spesso è più sottile. È tua madre che si aspetta di passare la vecchiaia circondata da nipoti, sono i parenti che aspettano che tu “metta la testa a posto”, è il datore di lavoro che ti guarda con dubbio, cercando di capire quando chiederai il congedo di maternità. Sono le amiche che si allontanano, risucchiate in un mondo di neonati e altre mamme, dietro muri di casa che diventano sempre più alti e spessi giorno dopo giorno, aspettando che anche tu faccia la trasformazione.
Questo perché in Italia, se sei una donna tra i 20 e i 40 anni, quello che la gente vuole davvero sapere da te è quando avrai dei figli – non “se” li vuoi, ma “quando” li avrai.
Gratta via lo strato di morbosa curiosità dietro la domanda e troverai il nucleo della società italiana, che basa il suo sistema patriarcale sull’identificazione delle donne nella figura della madre. Dopotutto, la nostra Prima Ministra l’ha reso abbastanza chiaro, ancora prima di diventare la prima donna a governare l’Italia. (In effetti, probabilmente per vincere il favore per diventarlo.) Nel suo discorso al raduno del Centro Destra a Roma il 19 novembre 2019, Meloni si è definita con quella che è diventata da allora una frase ad effetto (e che è stata persino remixata in una canzone di Myss Keta): “Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.” In altre parole, per essere una donna italiana, essere madre è uno degli identificatori più importanti. Questa è la tua funzione e la società si fonda su questo.
Ecco perché, quando salta fuori la domanda – che sia al classico pranzo con la famiglia allargata, tra amici che non si vedono da tanto, o a un colloquio di lavoro – la risposta che dai è estremamente importante, anche se potrebbe finire per rovinare la cena, dire addio per sempre a vecchi amici, o mandare a monte un’opportunità professionale.
Comincerò da me stessa, giusto per aprire una finestra su una realtà italiana quotidiana. Donna, nella seconda metà dei 30, nata in una piccola città del Nord-Ovest, educata all’estero, vissuta in giro per l’Europa, atea, ha avuto qualche storia d’amore finita male e qualche periodo da single, finalmente ha trovato un compagno. Non c’è stato un momento specifico in cui ho deciso di non avere figli, ma nemmeno ho mai sentito il bisogno di averli. L’unica volta che ho avuto una specie di istinto di procreare è stato quando ero molto giovane e vivevo in Danimarca. La sicurezza fornita da un sistema statale che offre servizi funzionanti e una società molto più egualitaria di quella italiana (per quanto riguarda i generi) erano cose tangibili, visibili anche per una studentessa ventenne che non aveva intenzione di metter su famiglia: bei padri giovani che portavano i figli a scuola in orari del giorno in cui, in Italia, sarebbero relegati nei loro uffici, che sembrano non poter esistere senza le loro presenze costanti; bambini piccoli imbacuccati in tute da sci che seguono i loro insegnanti su marciapiedi innevati; passeggini parcheggiati fuori dai caffè dove i genitori chiacchierano senza l’ansia di quello spettro tutto italiano che è il colpo d’aria. There in Denmark, although it was a time when I was completely focused on myself, I would not have minded becoming a mother. Because I did not envisage a transformation from “me” to “mother”, but an evolution from a single person to a person with children, which all in all seemed possible to integrate into one’s life, no matter one’s gender.
Una volta tornata in Italia, ho iniziato a incontrare amiche che decidevano di avere figli, o li avevano perché era semplicemente successo. Nessuna delle loro vite mi sembrava una scelta particolarmente desiderabile. Non voglio sminuire le loro gioie della maternità o la convinzione dei loro percorsi, solo che in nessun modo potevo vederlo coincidere con il mio, e per esattamente il motivo opposto a quello che avevo sentito nel Nord Europa. In Italia, ci si aspetta che le donne smettano di essere se stesse dopo aver avuto figli e diventino semplicemente madri. Certo, ci si aspetta anche che mantengano il loro lavoro, non sia mai che si pensi che siamo un paese retrogrado!

Il problema, però, arriva ben prima del momento della maternità e riguarda il mondo del lavoro. Nella classifica rilasciata a giugno 2024, il Global Gender Gap report, compilato dal World Economic Forum, l’Italia è scesa dalla già pessima 79ª posizione all’87ª (tra Timor-Leste, 86ª, e Ghana, 88ª, e seguita in Europa solo dall’Ungheria, 101ª): un punteggio in cui il 111° posto per l’indicatore chiamato “Partecipazione Economica e Opportunità” è particolarmente importante.
Molte donne in Italia scelgono un lavoro part-time sia perché stanno pianificando di avere figli sia perché li hanno già e ci si aspetta che si prendano cura dei piccoli a tempo pieno. Infatti, il 49,49% dei lavori part-time è svolto da donne, mentre il 23,03% è svolto da uomini. In cambio, il 20,40% del tempo libero delle donne è dedicato a lavori domestici e di cura non retribuiti, mentre solo l’8,40% del tempo libero degli uomini è utilizzato per questo scopo. Aggiungi a questo la differenza salariale quando il lavoro è retribuito; i dati mostrano che le donne italiane sono, in media, pagate il 6,1% in meno degli uomini. La media, però, non considera certi settori, come il settore privato, dove la differenza può arrivare fino al 15,5%, o l’età; sebbene il divario salariale sia del 3% per chi ha meno di 25 anni, raggiunge il 15,8% a 65 anni. (Questo potrebbe significare che il divario sta diminuendo per le generazioni più giovani, anche se potrebbe anche indicare che gli stipendi divergono più si sale nella scala aziendale – o che agli uomini vengono date più opportunità di crescita professionale.)
Dato il lavoro gratuito previsto a casa, la bassa retribuzione nel mondo del lavoro e un congedo parentale di 150 giorni, rispetto ai 14 previsti per il padre, non sorprende che molte donne abbandonino le loro prospettive di carriera, se non altro per non soccombere al pesante stress fisico e mentale. Ancora una volta, i numeri non mentono: solo il 15,30% dei ruoli di alta dirigenza in Italia è ricoperto da donne, e ci sono solo l’11,59% di aziende con maggioranza femminile.
Alcuni potrebbero sostenere che il divario salariale sia in realtà di pochi punti inferiore alla media europea, ma questo perché molte donne rimangono fuori dal mercato del lavoro. Secondo il rapporto annuale della Banca d’Italia, il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni era del 51,1% nel 2022 – alto rispetto agli ultimi tre decenni, ma del 18,1% inferiore a quello degli uomini; l’Italia ha il tasso più basso di partecipazione femminile alla forza lavoro nell’Unione Europea. Le ragioni non sono solo culturali ma anche economiche: spesso non vale la pena finanziariamente per una donna lavorare, poiché il denaro che guadagnerebbe sarebbe appena sufficiente per pagare una babysitter. Si potrebbe persino azzardare che la società italiana non solo vuole che le donne siano madri, ma le vuole anche a casa, poiché gli orari di asilo e scuola spesso non permettono a entrambi i genitori di avere una vita lavorativa normale.
Per dirla in breve, secondo l’Indice di Uguaglianza di Genere Europeo, “le disuguaglianze di genere (in Italia) sono fortemente pronunciate nel dominio del lavoro, in cui il paese ha costantemente occupato l’ultimo posto tra tutti gli stati membri dal 2010.”
Perché il tema del lavoro è così importante quando si parla di maternità? Immagina una giovane donna che ha studiato e lottato per farsi strada in uno dei tanti settori presieduti da manager uomini che sono per lo più sopra i 50 anni. Forse non è il lavoro che sognava all’università, ma una buona alternativa concreta. L’attuale sistema di maternità, che non richiede al padre di mettere in discussione il suo lavoro (e ruolo), la farà lentamente credere che non è così importante se perde la sua posizione, che alla fine non era quello che voleva davvero fare, che è meglio per lei non perdersi la crescita dei figli, meglio non spendere soldi per farli educare da estranei. Così si metterà in discussione ogni giorno, lasciando un vuoto di anni nella sua carriera, mentre il suo partner continuerà con il suo percorso professionale e non dovrà mai chiedersi “Ne varrà la pena?”.
Come qualcuno che ha passato la sua giovinezza a fare tutti i tipi di lavori per pagarsi gli studi, inseguendo borse di studio e titoli accademici, l’idea di non avere le stesse opportunità di un uomo mi riempie di rabbia, non di amore materno, proprio come l’idea di rinunciare a tutto per “il bene dei bambini” sarebbe un’opzione che mi renderebbe, almeno, triste e demotivata.
Beh, ovvio che il lavoro non è l’unica grana quando si parla di maternità in Italia. Potremmo parlare di come la Chiesa si ficca nel governo rendendo un casino abortire come mai prima. O di come la gente pensa che il potere delle donne sia legato alla Madonna. Potremmo parlare dei numeri spaventosi di femminicidi e di come i media li trattano come roba isolata senza scavare nel marcio di una società che non protegge le donne dalla violenza.

Al di là dei dati, da donna italiana, quello che per me offusca di più i sogni idilliaci di una famiglia felice è la totale mancanza, come società, di mettere in discussione la posizione del padre. Che si tratti di preparare la cena, pulire casa o l’aspettativa di non sconvolgere la propria vita: conosco pochissimi casi in cui la metà maschile di una coppia etero ha messo in discussione il proprio ruolo sociale e privato quanto la madre. Sto generalizzando? Forse. Purtroppo non ci sono dati ufficiali a supporto e la maggior parte delle donne che conosco, quando gli chiedi, ti raccontano i modi in cui il loro partner le sta “aiutando”. Ma penso che questa risposta, di per sé, sia un indicatore: perché dovrebbero “aiutare” a gestire la propria famiglia, la propria casa? Non dovrebbe essere un lavoro a due? In Italia, molto spesso, non lo è, ma molte donne si vergognano ad ammetterlo, come se avessero fallito il femminismo in cui credevano una volta, ma che semplicemente non può applicarsi alla loro vita quotidiana.
Il modo tutto italiano di dare per scontato questo carico, di sentirlo preteso da zie e nonne, normalizzato da amiche o in TV, è una violenza psicologica che pesa su molte più donne di quanto pensiamo. Fondere così profondamente il ruolo di donna con quello di madre influisce sull’identità e la singolarità di ognuna, relegandole a un modello forzato e vecchio che è stato così difficile abbandonare in questo paese. (Va notato che le donne che riescono a sfuggire a questa dinamica in Italia sono spesso quelle con la libertà finanziaria per comprare il supporto di cui hanno bisogno.)
Forse è per questo che mia nonna, dopo avermi chiesto “quando farai dei figli?” mentre ero in relazioni disfunzionali, alla fine si è risolta a chiedermi perché non li facessi e basta, con chiunque capitasse, come se non facesse molta differenza se il padre fosse presente nella crescita del bambino.
Quindi, per farla breve, una buona risposta alla domanda “quando farai dei figli?” potrebbe essere “quando l’Italia smetterà di essere un paese sessista, che discrimina le donne nel mondo del lavoro e si aspetta che si annullino per crescere i figli”. Un’altra, altrettanto valida ma che rompe tutti i paradigmi, è “perché non ne voglio”.