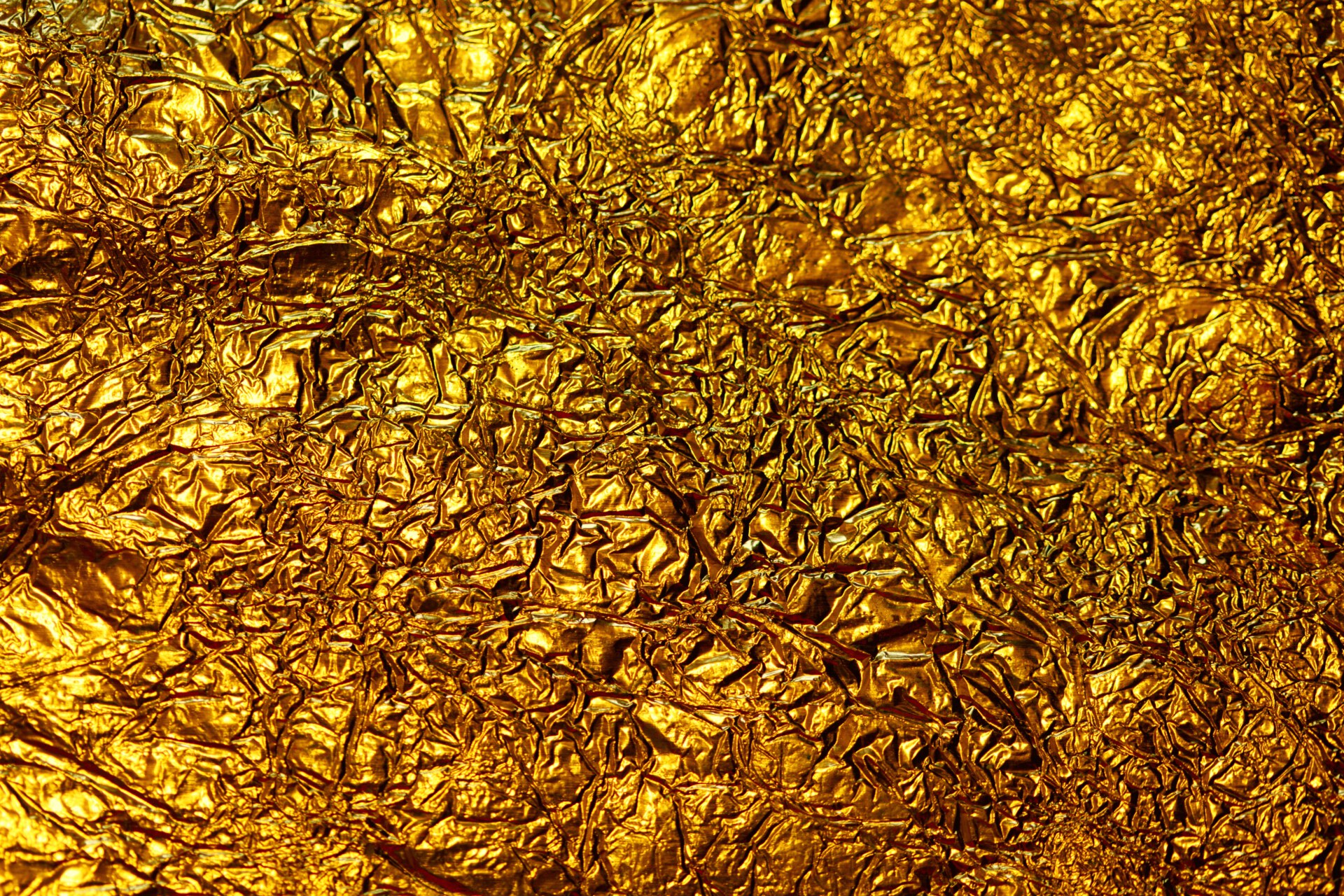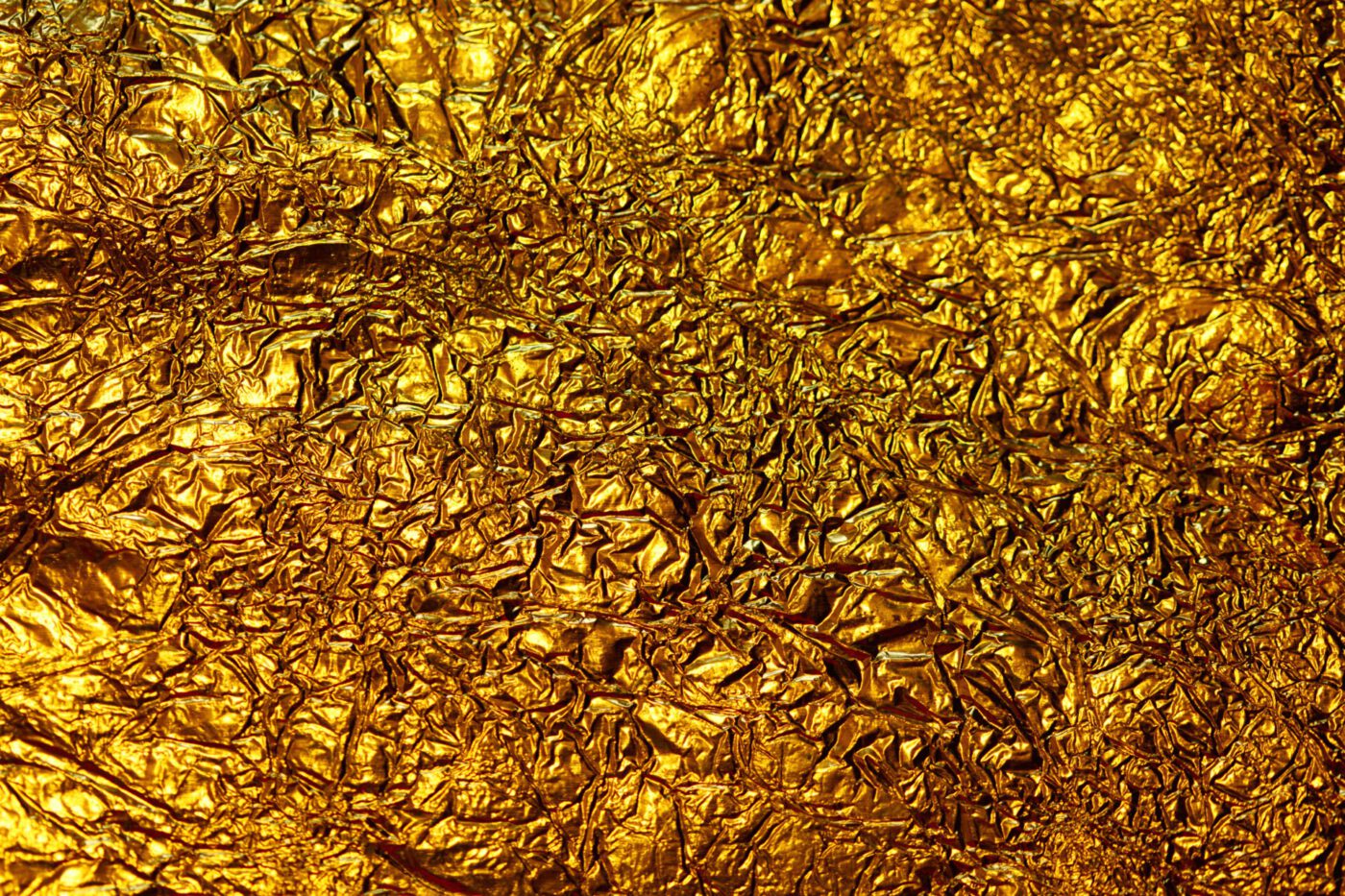Dicono che gli occhiali rosa siano il modo migliore per vedere il mondo, ma hai mai provato quelli d’oro? Io sì, e non sono il primo a guardare la vita attraverso una foschia dorata; l’uomo ha cercato l’oro da tempo immemorabile. Alcuni sono impazziti nel perseguirlo. Oro degli stolti. Avrebbero dovuto risparmiare la loro sanità mentale. Perché c’è un posto dove le lenti dorate non sono necessarie per vedere meglio: Venezia. Perché a Venezia, tutto è oro.
In una serata di fine estate poco prima del tramonto, una passeggiata per Venezia è come seguire le orme di Mida. L’ebano lucidato gondole nere che scivolano lungo i canali hanno linee metalliche dorate come contorni, e putti dorati (cherubini) incorniciano quelli nel loro viaggio acquatico attraverso la città. Appena sopra la linea dello sguardo, il leone di San Marco, con fessure ambrate per occhi, guarda dall’alto sopra le porte e dalle bandiere che sventolano al vento, dirigendo i tuoi movimenti con più intenzione dei cartelli ” Per San Marco” in giallo sbiadito. Inevitabilmente trascinato dalla marea verso Piazza San Marco, ti ritrovi al centro del sistema solare, abbagliato dal suo splendore. Tutti gli occhi sono attratti dall’epicentro, dalla Basilica di San Marco. La sua facciata vanta mosaici di mezzi soli dorati che cambiano con le ore come il passaggio del sole nel cielo. A mezzogiorno, sono di un giallo brillante; al tramonto, sono d’oro brunito; e a mezzanotte, brillano dall’interno, proiettando inquietanti ricordi di tutto ciò che hanno visto nel corso dei secoli.
Una mattina presto di fine gennaio, ho attraversato Piazza San Marco come ho fatto innumerevoli volte prima. La nebbia della laguna giaceva come un tappeto, sfumando il confine tra terra e mare – un confine che è sempre transitorio a Venezia. L’aria era così densa che i primi passanti del mattino emergevano come fantasmi dalle sue profondità. Le immense porte della basilica si stagliavano alla vista, solennemente chiuse, mentre una porta laterale più piccola e meno imponente mi invitava ad entrare, un gradito riparo dall’ambiente grigio. Era l’ora della messa, ma non ero lì per pregare: ero venuto con una missione. Oltre l’abside nella sacrestia, c’è un altro schema di affreschi (forse disegnato da Tiziano), che può essere accessibile solo ai fedeli, ma che io, l’eternamente determinato storico dell’arte, dovevo vedere. Taccuino – rilegato in tessuto Fortuny dorato – in mano, aspettavo pazientemente, i miei occhi vagavano per le pareti. La luce del giorno non era ancora spuntata, e con la poca luce, forme ombrose si stagliavano dal buio. Da una parete, gli apostoli guardavano furtivamente, mentre Cristo mi guardava dall’alto. L’orologio segnò le 8:00 e apparve il prete. “Sei qui per la messa?” sussurrò, e lo seguii in un’altra stanza ricoperta dal pavimento al soffitto di scintillanti mosaici di Cristo e degli Apostoli. Missione compiuta, messa frequentata e anima purificata, tornai nella basilica proprio mentre il sole del mattino iniziava a filtrare attraverso le finestre. I raggi colpivano i loro bersagli dorati: particelle d’oro rimanevano sospese nell’aria, ricordandomi la principessa Danae catturata in una pioggia d’oro.
Ho notato per la prima volta un’ossessione italiana per l’oro non a Venezia, ma a Roma. Era inizio settembre e tutti erano tornati in città dalle vacanze di Ferragosto, mostrando orgogliosamente i loro corpi abbronzati dalla spiaggia. Durante una deviazione dalle mie solite zone di Trastevere, mi sono ritrovato vicino a Piazza di Spagna e ho deciso di dirigermi verso i giardini dell’Hotel de Russie per una pausa dalla folla di turisti. Mentre aspettavo il mio Americano Arrivato, sono tornato a quell’intramontabile passatempo di osservare la gente. Alla mia sinistra, una signora con le dita coperte di anelli d’oro sorseggiava un espresso; poco più in là, due tizi si fumavano dei sigari, con grossi bracciali d’oro ai polsi e mocassini con loghi dorati ai piedi; un’altra donna è passata, con la sua ultima borsa dorata che luccicava sul braccio. Più guardavo, più oro vedevo. E poi ho capito: Versace, Dolce Gabbana, Roberto Cavalli… tutti attingono a una passione italiana per l’oro che è l’eredità dell’Impero Romano.
A Venezia, questa smania per l’oro non era nutrita da un debito verso Roma, ma verso la “Nuova Roma”: Istanbul. Dal 4 ° secolo, i Bizantini incastonarono i loro dei in mosaici d’oro, alimentando la febbre dell’oro; quando arrivarono a Venezia come ambasciatori, portarono questa visione scintillante. Gli artigiani disposero piccoli quadrati d’oro in un puzzle celestiale sulla Basilica di Torcello, prima di volgere lo sguardo attraverso la Laguna e dedicare la loro attenzione al capolavoro che custodisce il corpo di San Marco. C’è mai stato un santuario più grande di quello costruito nel corso dei secoli, pezzo per pezzo, oro su oro? E a coronare il tutto c’è l’altare maggiore della Basilica di San Marco, la Pala d’Oro: tre metri di larghezza e due metri di altezza di strato su strato di oro massiccio, tempestato di perle, rubini, ametiste – la pala d’altare definitiva. San Marco non è solo un luogo di culto, ma un santuario dedicato all’auromania: l’ossessione per l’oro.


Studiando il passato di Venezia ti fai un’idea dei bei tempi andati, della posizione chiave di Venezia sulla Via della Seta quando tutti i materiali preziosi passavano per i suoi porti, di un periodo d’oro in cui l’oro veniva usato come se stesse passando di moda. Le pale d’altare dei primi anni del 1400 erano fatte con oro macinato in una sfacciata dimostrazione di ricchezza e status; col passare dei secoli, impararono a moderarsi un po’. Il pittore rinascimentale Giovanni Bellini usava l’oro nelle sue pale d’altare solo per imitare i mosaici di San Marco, mentre nell’Assunta di Tiziano nella chiesa di Santa Maria dei Frari, il bagliore dei cieli era creato con poco più che pigmenti arancioni e gialli sospesi nell’olio… non è tutto oro quello che luccica. Le processioni per la città erano accompagnate da candelabri dorati più grandi degli uomini che li portavano. Quando i veneziani commissionarono una nuova struttura per accogliere i marinai di ritorno e gestire le dogane alla Punta della Dogana, non poterono resistere alla tentazione di dorare il globo sorretto da figure erculee, con i corpi piegati sotto il peso del metallo. Un mercante veneziano arrivò persino a dorare l’intera facciata del suo palazzo sul Canal Grande. Quante ore ho passato sulla Riva de l’Ogio, guardando verso quella leggendaria residenza, la Ca’ d’Oro, cercando di immaginare come potesse apparire un tempo? Ora l’oro si è ritirato in angoli nascosti, ma a volte quando questi frammenti catturano la luce, brilla un’ombra del suo antico splendore.
Una città scolpita nell’oro richiede artigiani capaci di lavorare un metallo dalle qualità alchemiche. Nessuno merita più il titolo di Goldfinger di Marino Menegazzo, la cui famiglia è orafa dal 1926. Sotto il suo regno come custode del laboratorio artigianale di oro Berta Battiloro, blocchi solidi di oro puro vengono fusi e battuti in fogli più sottili della carta e più fini dell’aria, poi rilegati in libri da sogno per un bibliotecario. Questa è l’ultima roccaforte dei mestieri del batti e tira oro (letteralmente ”battere e tirare l’oro”) che al suo apice nel 1700, era praticato da più di 40 botteghe in tutta la città. Gli antenati di Mario hanno costruito i blocchi di Venezia per secoli, e lui mantiene quel ruolo ancora oggi come fornitore degli artigiani della città. Da Angelo Orsoni, l’ultima fornace di mosaici di Venezia, i quadrati di mosaico sono ancora costruiti da minuscoli pezzi di foglia d’oro sospesi tra vetri. I pochi soffiatori di vetro rimasti a Murano dipendono dalla foglia d’oro per la foglia d’oro tecnica che hanno perfezionato nel corso delle generazioni. Sull’isola di Mazzorbo, nel rinomato ristorante Venissa, la foglia d’oro di Battiloro decora le bottiglie di Dorona dell’azienda: l’ultimo baluardo sopravvissuto di quest’uva dorata che un tempo era coltivata nei vigneti di tutta la Laguna Veneta.
Perché parlo di “l’ultimo”? Quando mi incontro con gli amici veneziani per Cene di cicchetti nei nostri locali preferiti del quartiere , la nostra chiacchierata inevitabilmente oscilla tra il passato e il futuro di Venezia. Riflettiamo sulle cose che rimangono uguali da secoli e ricordiamo i locali che hanno abbandonato la città in cerca di terreni più sicuri. Ci chiediamo: le tanto attese barriere anti-alluvione funzioneranno davvero? O l’immagine di Venezia non sarà più quella della “città gioiello, tutta intarsiata e incastonata” di Italo Calvino, ma una Città Invisibile come Atlantide? La gente potrebbe raccogliere i propri averi e andarsene, ma le strutture che rendono questa città un gioiello sono destinate a un fato acquatico. Se attraversi Piazza San Marco poco prima Acqua Alta in una notte deserta, quando i riflessi degli edifici circostanti si rispecchiano nell’acqua di mare che si accumula nella piazza, puoi immaginare come potrebbe apparire.
Parlare del passato e del futuro non significa dimenticare il presente di Venezia. Nel corso dei secoli, il sangue che scorre nelle vene veneziane si è trasformato in oro liquido: la creatività e le tradizioni culturali pulsano con una forza vitale. I veneziani si rifiutano di lasciar morire il loro patrimonio, restaurando il loro regno dorato con la testardaggine di un popolo che ha perfezionato l’arte di costruire terra sull’acqua. Nuovi pezzi del puzzle di 1400 anni vengono incastrati nella cattedrale di Torcello; gli specchi vengono ridorati, mettendo in risalto la patina accumulata nei secoli sul vetro; i mobili antichi vengono rivestiti con fili d’oro. Il senso dell’umorismo veneziano, stranamente secco, fa sì che spesso ci sia un gioco da fare. La prima sera che sono tornato al Ristorante Quadri dopo la ristrutturazione, i volti dei fratelli Alajmo, Max e Raf, mi guardavano dall’alto, intessuti in filo d’oro nel tessuto Bevilacqua che ricopre le pareti. Dopo mezzanotte, davanti a dei negroni, ho chiesto a Giovanni, il figlio di Raf e ora manager del Quadri, perché l’oro sia così importante per la sua famiglia. Mi ha semplicemente guardato e ha risposto: “L’oro per noi è un simbolo di resistenza contro l’acqua alta e il passare del tempo, perché la sua bellezza non sbiadisce mai.” Non c’era bisogno di altre spiegazioni.
Forse questa infatuazione veneziana per l’oro può essere riassunta in un singolo evento: la Festa della Sensa. Mentre il resto d’Italia celebra il giorno dell’Ascensione di Cristo in cielo, i veneziani guardano giù nella loro Laguna. Con tutto il necessario sfarzo, una regata guidata da una barca dorata – con remi d’oro e un tritone dorato al timone – parte per il monastero di San Nicolò al Lido. L’evento culmina con il sindaco che getta un anello nuziale d’oro nelle acque scintillanti – un’unione simbolica con il mare. È un rituale che viene praticato da 1000 anni. Innumerevoli anelli d’oro vengono ora trasportati dalla corrente attraverso la Laguna, trasformando Venezia in una città d’oro sopra e sotto l’acqua.