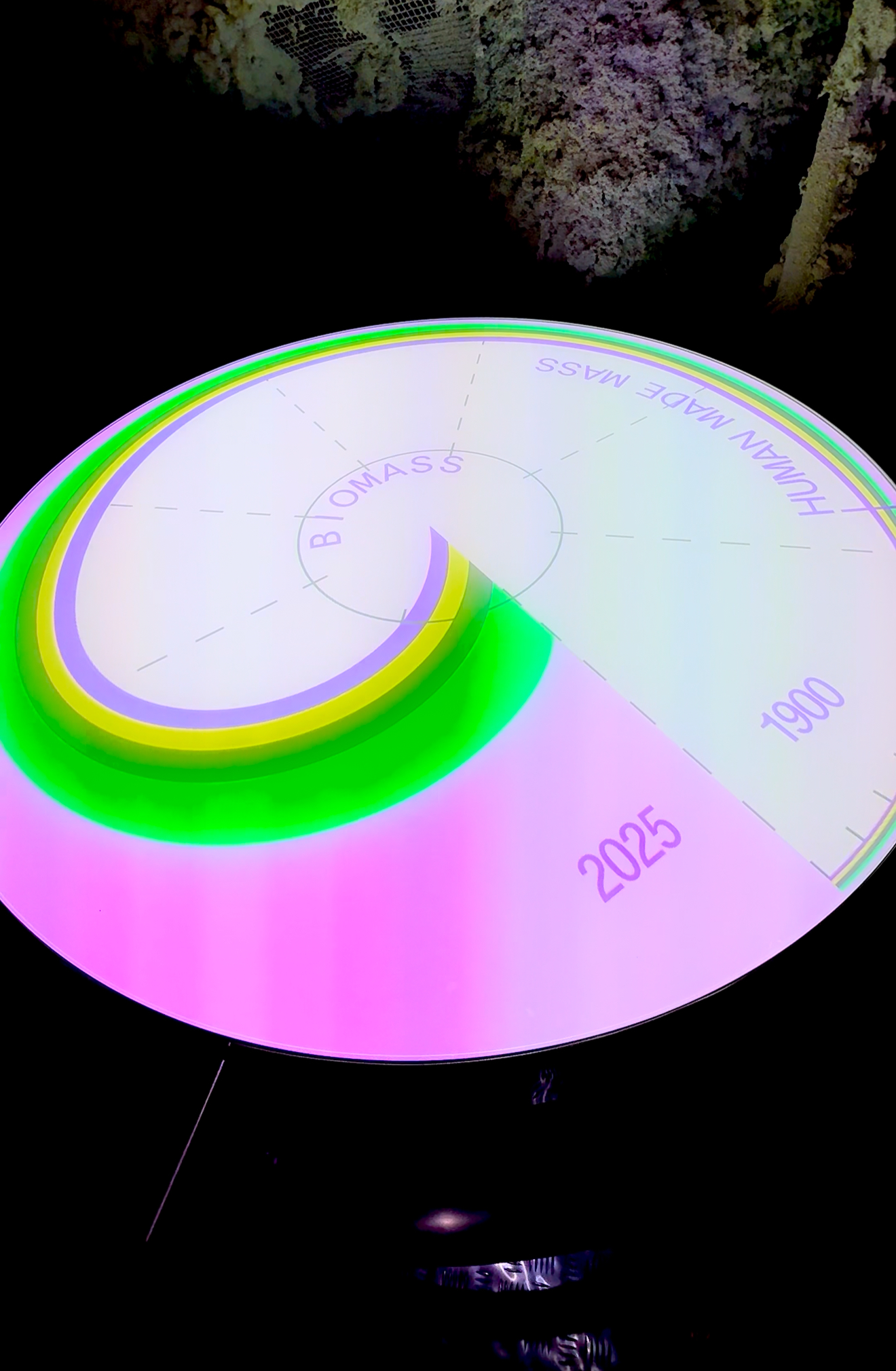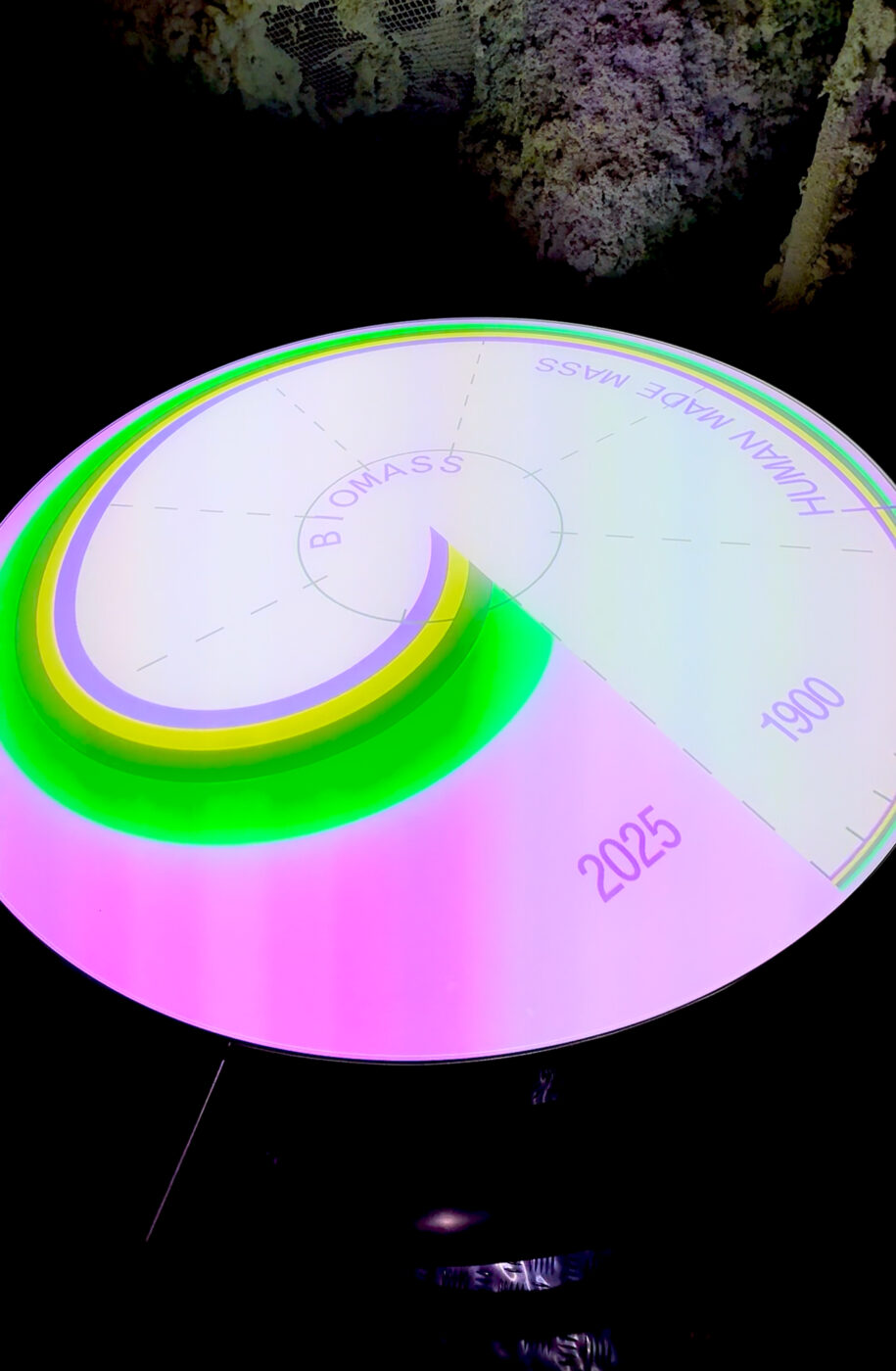Quando pensiamo a Venezia, ci vengono in mente tanti aggettivi: romantica, storica, pittoresca, senza tempo. Ma sostenibile? Forse no. È difficile pensare a Venezia come a un posto sostenibile. Anzi, a prima vista, sembra proprio il contrario: una città costruita su una foresta di pali di legno piantati nel fango di una laguna; un’utopia sostenuta solo dall’ottimismo, dall’ingegno e, come dice l’UNESCO nel suo elenco dei Patrimoni dell’Umanità, dalla “lotta vittoriosa contro gli elementi”. E se questa continua tensione tra lo sforzo umano e la natura ha funzionato per gli ultimi 16 secoli, oggi sembra che ci si concentri sempre di più sulla lotta in sé. L’innalzamento del livello dell’acqua, i cambiamenti ambientali nell’ecosistema della laguna e le maree alte sempre più frequenti e devastanti – insieme al turismo di massa che mette a dura prova il tessuto urbano e sociale della città – stanno erodendo costantemente la capacità di Venezia di resistere.
“Se guardassimo solo dal punto di vista finanziario, dovremmo lasciarla affondare”, ha scherzato una volta un mio amico che lavora nel business e nell’economia. Ma ovviamente, non è un’opzione. Ed è per questo che, da decenni ormai, Venezia è al centro dell’attenzione e dell’azione in ambito di ricerca, letteratura, giornalismo e iniziative private, tutte concentrate su come la città possa non solo sopravvivere, ma prosperare, nonostante le circostanze attuali così difficili. L’obiettivo è posizionare Venezia non solo come un posto da salvare, ma come un centro di cambiamento e adattamento – un luogo dove le sfide che vediamo chiaramente stanno avvenendo, su scala diversa e in varie forme, in tutto il mondo.
Salvatore Settis ha ragione quando, nel suo libro, Se Venezia muore, descrive Venezia come una macchina pensante – una cassetta degli attrezzi universale di concetti attraverso cui possiamo riflettere sull’idea stessa di città. Venezia, scrive, è una macchina per contemplare la natura della vita urbana e le pratiche della cittadinanza – la vita in città come sedimentazione storica, come esperienza vissuta nel presente e come progetto per un futuro possibile. Guardare Venezia e pensare solo a Venezia, sostiene, è fuorviante: i processi che si stanno svolgendo lì – in particolare il degrado e lo spopolamento del centro storico, la retorica di una modernità standardizzata e la fissazione sul profitto – rispecchiano quelli che accadono in molte altre parti del mondo. Ecco perché, al contrario, può essere illuminante esaminarli da vicino e con qualche esempio per vedere cosa si può applicare anche altrove.
Tra le iniziative più ottimistiche per ridefinire Venezia come modello c’è la Fondazione Venice World Sustainability Capital. Operando sotto lo slogan “la città più antica del futuro”, mira a fare di Venezia “un punto di riferimento per la qualità della vita urbana – un esempio che può ispirare altri contesti nazionali e internazionali” attraverso la creazione di un modello integrato che lavori verso un futuro sostenibile per la città e il suo territorio circostante. “Grazie alle sue piccole dimensioni e alle sue peculiarità territoriali, Venezia è un laboratorio ideale per generare, sviluppare e testare un nuovo modello di sostenibilità urbana – sociale, economica e ambientale – come felice sintesi tra resilienza passata e prosperità futura”, afferma il sito web della Fondazione.
Tuttavia, la Fondazione è stata spesso accusata di essere poco più di un esercizio di greenwashing – un’impresa ipocrita e fumosa, priva di un piano d’azione concreto e di un quadro finanziario dettagliato, il tutto mentre annovera tra i suoi stakeholder politici di spicco e compagnie petrolifere e del gas. È vero che Venezia è ancora tra le prime città italiane per inquinamento dell’aria e dell’acqua, a causa di una serie di fattori tra cui infrastrutture fognarie inadeguate, trasporti pubblici inquinanti e l’elefante nella stanza: la pesante presenza industriale del conglomerato di Porto Marghera. Per non parlare della questione degli affitti brevi e della gestione del turismo.
Mentre gli amministratori locali introducono misure controverse – come il biglietto d’ingresso durante l’alta stagione – senza soddisfare le richieste dei residenti per, ad esempio, politiche abitative adeguate e altre questioni urgenti, sta diventando sempre più chiaro che un’azione significativa, anche se su piccola scala, legata al cambiamento sostenibile non è guidata da grandi istituzioni, ma piuttosto da iniziative dal basso e sforzi di ricerca. Questi spesso collegano il lavoro accademico con il coinvolgimento attivo di associazioni locali e individui che lavorano in una vasta gamma di campi – dall’architettura all’urbanistica, dagli studi ambientali al cibo e all’ospitalità, e dall’attivismo alle arti visive e alla letteratura.

Un esempio di questo è Vital, un progetto guidato da un gruppo di esperti focalizzato sulla manutenzione e valorizzazione del capitale naturale della Laguna di Venezia. “Il patrimonio ecologico della Laguna è considerato una forma di capitale naturale che genera varie forme di ricchezza. Vital si impegna a trovare modi per proteggere e valorizzare questo capitale naturale a beneficio delle generazioni presenti e future,” dice Margherita Scapin, ricercatrice in scienze ambientali e attivista con l’ONG We Are Here Venice, e membro del team di Vital.
Jane da Mosto, fondatrice di We Are Here Venice, descrive la città come “uno specchio sul mondo: una fonte di ispirazione e un microcosmo di molte delle sfide globali più importanti.” Attraverso l’organizzazione, promuove approcci strategici e partecipativi per la salvaguardia sia della città che della sua laguna, sostenendo uno sviluppo sostenibile basato su prove scientifiche e ricerca. Tra le molte campagne lanciate da We Are Here Venice c’è #veneziaèlaguna, un’iniziativa di comunicazione che evidenzia la cruciale interdipendenza tra la città e l’ecosistema in cui esiste. “La sopravvivenza di questo ambiente è stata garantita nel corso dei secoli da interventi umani pianificati. Poiché la Laguna è il risultato dell’incontro tra le acque salate dell’Adriatico e i fiumi della pianura veneta, il suo equilibrio è naturalmente precario—minacciato, da un lato, dalla possibilità di insabbiamento totale e, dall’altro, dall’invasione delle acque marine. Le attività di Vital fanno parte di una tradizione di interventi mirati a ripristinare questi processi dinamici ottimali,” aggiunge Scapin.
Infatti, recenti ricerche hanno identificato diversi approfondimenti critici riguardo Venezia e la sua laguna come punti focali per il cambiamento climatico, rivelando significativi cambiamenti sia nel clima della regione che nei suoi ecosistemi. Negli ultimi tre decenni, il livello medio relativo del mare a Venezia è aumentato di circa 4,9 mm all’anno, portando a eventi di alluvione più frequenti e prolungati. Le proiezioni suggeriscono che, nei peggiori scenari, i livelli del mare potrebbero aumentare fino a 3,47 metri entro il 2150 durante eventi di alta marea estrema, potenzialmente sommergendo ampie porzioni della laguna. Nel frattempo, l’Adriatico settentrionale si è riscaldato di 1,8°C nello stesso periodo, superando la media globale e oltrepassando le soglie stabilite dall’Accordo di Parigi.
La natura poco profonda della laguna esaspera questi cambiamenti di temperatura, in particolare nelle piane di marea, minacciando l’equilibrio delicato dei suoi ecosistemi. Con l’aumento del livello del mare e delle temperature, la biodiversità della laguna è a rischio, con il potenziale per migrazione di specie, interruzione degli habitat e predominanza di specie non native (vedi l’invasione del granchio blu—ne parleremo tra poco). Mentre le barriere anti-alluvione MOSE, installate nel 2020, hanno mitigato con successo le alte maree, hanno introdotto nuove sfide. Queste barriere hanno ridotto lo scambio d’acqua tra la laguna e il mare, potenzialmente peggiorando le ondate di calore marine in estate e le ondate di freddo in inverno. Inoltre, le barriere hanno alterato i modelli di deposizione dei sedimenti, portando alla formazione di nuove conformazioni terrestri, come Bacan—un tempo isola sabbiosa transitoria che ora è diventata un’isola permanente. Sebbene tali cambiamenti creino nuovi habitat e spazi ricreativi, evidenziano anche la complessa relazione tra interventi umani e i processi naturali di questo spazio liminale.

“Una questione ancora poco esplorata ma cruciale per Venezia e la sua laguna è il riconoscimento dei diritti della natura all’interno dell’ecosistema lagunare”, dice Alice Ongaro Sartori, ricercatrice in cultura visuale e curatela editoriale con un focus su ecologia e sfera pubblica, che si occupa anche della comunicazione sociale presso wetlands, una casa editrice veneziana dedicata alla giustizia sociale e alla sostenibilità ambientale. “Introdurre questa prospettiva nella sfera legale non solo porterebbe a una protezione ambientale più efficace, ma rimodellerebbe anche il modo in cui percepiamo e ci relazioniamo con il paesaggio nella nostra vita quotidiana. La letteratura può giocare un ruolo in questo cambiamento – e infatti, noi di wetlands stiamo lavorando in questa direzione.”
In risposta alle questioni urgenti e complesse del nostro tempo, wetlands si è impegnata a pubblicare testi che esplorano temi ambientali, urbani, sociali, antropologici e culturali – con un’enfasi particolare su Venezia e la sua laguna, pur coinvolgendo prospettive più ampie e transnazionali.
Come possono la letteratura e l’editoria aiutare a riformulare la narrativa di Venezia nel contesto delle sue sfide – soprattutto considerando che queste si riflettono in altre regioni? “Amitav Ghosh, in The Great Derangement, sottolinea come le narrazioni tradizionali abbiano spesso messo in secondo piano il cambiamento climatico, trattandolo come un’eccezione piuttosto che una condizione vissuta quotidianamente. Pubblicare libri che collegano Venezia alla crisi climatica, all’innalzamento del livello del mare e al turismo di massa aiuta a reimmaginare la città non come un luogo destinato a scomparire, ma come un laboratorio vivente – che produce attivamente conoscenza e immagina futuri alternativi,” spiega Ongaro Sartori. “Una casa editrice attenta a questi temi può amplificare voci diverse – da scrittori e artisti ad attivisti e scienziati – mettendo Venezia in dialogo con altre città vulnerabili. Ci permette di capire che, sebbene questi siano problemi globali, possono anche essere affrontati collettivamente.”

Architecture Biennale 2025; Intelligens. Natural. Artificial.
Mentre Venezia si prepara per un’altra Architecture Biennale che aprirà l’8 e 9 maggio 2025, il suo tema, Intelligens. Natural. Artificial. Collective , sotto la guida curatoriale di Carlo Ratti, invita “diversi tipi di intelligenza a lavorare insieme per ripensare l’ambiente costruito” e a “sperimentare oltre l’attuale focus limitato sull’IA e le tecnologie digitali.” Afferma inoltre che, quando “i sistemi che hanno a lungo guidato la nostra comprensione iniziano a fallire, sono necessarie nuove forme di pensiero. Per decenni, la risposta dell’architettura alla crisi climatica si è concentrata sulla mitigazione – progettare per ridurre il nostro impatto sul clima. Ma quell’approccio non è più sufficiente. È giunto il momento che l’architettura abbracci l’adattamento: ripensare a come progettiamo per un mondo alterato.”
Eppure, è in parte a causa di grandi eventi annuali come la Biennale che la città è diventata sempre più insostenibile. “Come architetto e direttore di una piattaforma culturale open-access, sono scoraggiata da come i principali attori culturali capitalizzino sulla programmazione stagionale in linea con il calendario della Biennale – una forma di estrazione che sfrutta la capacità unica de La Serenissima di attrarre un vasto numero di persone,” dice Federica Sofia Zambeletti, fondatrice e direttrice di KoozArchKoozArch, uno studio di ricerca e una piattaforma per il dibattito architettonico critico. Attraverso una rivista, mostre ed eventi, KoozArch abbraccia un approccio multigenerazionale e multidisciplinare, sfidando la natura storicamente ed evidentemente estrattiva dell’architettura a favore di una forma di pratica più rigenerativa e accessibile. “Questa capitalizzazione fa sì che migliaia di metri quadrati di spazio (dagli appartamenti a interi edifici storici, persino isole) rimangano inutilizzati e inaccessibili per sei mesi all’anno. In questo senso, una forma di abitazione diversa e più sostenibile – almeno da una prospettiva culturale – sarebbe quella di concepire una programmazione sostenibile per tutto l’anno. Questo potrebbe considerare come tali spazi possano essere mobilitati per rispondere alle necessità dei veneziani, una rara specie di persone resilienti che – nonostante le difficoltà – continuano ad abitare e curare la laguna con orgoglio.”
Quando si guarda a cosa si potrebbe fare in termini di architettura rigenerativa nella laguna, Zambeletti afferma: “Ancora una volta, penso che si tratti di riappropriarsi di spazi per la collettività e di riportare a terra la nozione spesso appiattita di rigenerazione come pratica veramente sociale. Per fortuna, ci sono diverse iniziative che lavorano in questa direzione: lo spazio di co-working recentemente stabilito, Versatile e il più storico BoccioFila culturale sono ottimi esempi di spazi rivendicati e salvaguardati per le esigenze dei cittadini locali. A livello infrastrutturale, il lavoro di OCIO Venezia nella raccolta, analisi e monitoraggio della situazione abitativa a Venezia è fondamentale per capire come sta cambiando la città e quali azioni devono essere intraprese per contrastare le criticità più evidenti. Ovviamente, c’è molta forza nei progetti che attivano spazi sottoutilizzati o abbandonati, nutrendo collaborazioni tra attori locali e globali; per esempio, il Cinema Galleggiante o l’ambizioso progetto per l’Isola di Sant’Andrea, entrambi sotto la guida di Paolo Rosso.”

Un approccio simile, guidato dalla comunità e multidisciplinare, si può vedere nel lavoro di Amina Chouaïri, una studentessa di dottorato in Urbanistica presso IUAV che ricerca il ripristino ecologico delle barene (paludi) nella laguna attraverso la lente dell’architettura del paesaggio come modo per rivelare le sue incoerenze. “Credo che il momento presente della laguna sia il più importante, ma anche il più trascurato. Si dà molta attenzione al patrimonio e alla nostalgia per ciò che una volta era – il declino che stiamo vivendo da due secoli – mentre, d’altra parte, c’è una forte attenzione al futuro, in particolare guardando al 2050. Ma sebbene questo abbia implicazioni per il presente, il presente stesso rimane in gran parte assente dal discorso critico.”
In questo senso, sia come ricercatrice che come residente di Venezia, si è sentita spinta a dedicare tempo allo stato attuale della laguna essendo fisicamente presente in essa. “Ho sentito il bisogno di stare fuori, immersa nell’ambiente, perché continuando i miei studi mi sono resa conto che questo aspetto mancava un po’.” Si è subito accorta che questo forte desiderio di vivere il paesaggio in scala 1:1 era ampiamente condiviso. In risposta, ha iniziato ad organizzare uscite – sia formali (in collaborazione, per esempio, con istituzioni come Ocean Space e TBA21, o in collaborazione con l’associazione ambientale ed educativa Barena Bianca) che informali – prendendosi il tempo di esplorare la laguna con amici e offrendo momenti di divertimento con un tocco riflessivo.
“Una di queste uscite ha portato all’idea di un progetto fotografico con Matteo De Mayda, mentre un’altra ha ispirato il Convivio Acquatico (un simposio culinario) con il “collettivo conviviale” Tocia!, guidato dallo chef Marco Bravetti, e il videomaker Matteo Stocco. Mi piace l’idea di organizzare e fare qualcosa di tangibile, mettendo insieme realtà diverse. Tutto questo fa parte di una volontà condivisa di creare connessioni all’interno del paesaggio e del luogo stesso.”
“Direi che negli ultimi 50 anni, dai grandi movimenti ambientalisti del XX secolo, la consapevolezza ecologica e gli sforzi per conservare e proteggere la laguna sono cresciuti enormemente,” dice Chouaïri. “Oggi, queste questioni sono portate avanti – a volte in modo frammentato, altre volte in modo più coeso – dalle associazioni ambientaliste rimaste. Allo stesso tempo, riconosco le sfide interne all’attivismo a Venezia. È diffuso e, di conseguenza, a volte sorgono conflitti, creando una frammentazione a mosaico, anche se gli obiettivi finali rimangono allineati.”

Mi sono unito anch’io a una delle escursioni in barca organizzate da Chouaïri e Fabio Cavallari di Barena Bianca attraverso la laguna nord. Lo scopo della spedizione era esplorare abitudini alimentari alternative e il concetto di resistenza culinaria in relazione a questo ambiente unico, anfibio e liminale.
Durante la prima parte della mattinata, alcuni relatori hanno letto passaggi toccanti da libri sulle isole di Venezia, in particolare da Ultime Isole di Paolo Barbaro. A questo è seguita una discussione incentrata sul perché, nella nostra epoca attuale – quando il cambiamento climatico presenta sfide così urgenti – è vitale cambiare la nostra prospettiva sul mondo naturale. Invece di chiederci cosa queste paludi e zone umide possano fare per noi, dovremmo considerare come potremmo adattarci a vivere in armonia con esse. È possibile? Possiamo imparare a osservare la natura senza cercare di domarla? Può succedere qui, in un luogo che spesso è visto come bisognoso di essere salvato? Persino il sistema di barriere contro le inondazioni MOSE, ha fatto notare un relatore, è un intervento imperfetto, temporaneo e molto criticato – eppure, per molti versi, continua la lunga tradizione dei tentativi di Venezia di gestire il suo ambiente instabile. Si è convenuto che, per stabilire un vero dialogo con questo paesaggio in continuo cambiamento e fragile – fragile nel senso di instabile – dobbiamo iniziare a vivere in più stretta simbiosi con il nostro ambiente, facendo domande migliori e cercando risposte migliori.
La conversazione si è presto spostata sul cibo e, più tardi nel corso della giornata, è continuata su questo filo durante una visita a I Sapori di Sant’Erasmo, un’azienda agricola a conduzione familiare sull’isola omonima. Lì, Fiorella “Cosetta” Enzo, la proprietaria, ha generosamente condiviso la sua ricchezza di conoscenze empiriche e tecniche mentre sedevamo sotto la sua pergola ombrosa, affaticati dal sole implacabile in quello che era il primo giorno caldo dopo settimane. Abbiamo parlato di gestione dell’acqua e degli effetti locali del cambiamento climatico, che sembrano assumere un carattere sempre più tropicale – stagioni piovose più lunghe e siccità prolungate che stanno mettendo sotto notevole pressione le piante native. Un partecipante ha chiesto del carciofo – in particolare della pregiata varietà a forma di tulipano chiamata carciofo violetto (carciofo viola), così emblematico di Sant’Erasmo. Cosa lo rendeva così speciale, si chiedevano? “Non è la pianta ad essere unica”, ha risposto Cosetta. “Chiunque potrebbe prendere questa varietà e provare a coltivarla altrove. Ma solo qui queste piante hanno trovato questo terreno, con il suo perfetto equilibrio di argilla e sale.”
Ha parlato di costruire una comunità di coltivatori che potessero sostenersi a vicenda e agire come custodi della terra. Le offerte per comprare la sua terra arrivavano quasi ogni giorno, ha detto Cosetta, ma lei rimaneva ferma sulla sua decisione di restare; quel posto era tutta la sua vita. Tuttavia, ha riconosciuto che il futuro dell’isola rimaneva incerto, fortemente dipendente dalle intenzioni degli eredi dell’attuale generazione di coltivatori che invecchia. Con poche eccezioni, molti probabilmente avrebbero venduto al miglior offerente – molto probabilmente uno sviluppatore straniero – e semplicemente sarebbero andati avanti, minando così la vocazione naturale di un’isola – Sant’Erasmo – che, per secoli, ha agito come “l’orto di Venezia”, essendo non solo la più grande all’interno della laguna ma anche una delle più fertili.

Non lontano dall’azienda di Cosetta si trova un’altra iniziativa agricola, Osti in Orto, un progetto collaborativo lanciato alla fine del 2020 da 13 ristoratori veneziani, guidati da Cesare Benelli di Al Covo. Con l’obiettivo di aggirare le catene di approvvigionamento tradizionali e riconnettersi con il territorio locale, l’iniziativa coltiva verdure specificamente per l’uso nelle cucine dei ristoranti partecipanti, rivitalizzando così i terreni agricoli locali e offrendo una vasta gamma di piatti di verdure ricchi di sapore ai clienti del ristorante. L’appezzamento di quattro ettari è gestito da Mario Saviolo, un locale con un background in biotecnologia ambientale, e segue pratiche tradizionali come la semina in armonia con i cicli lunari. Osti in Orto offre anche un’esperienza immersiva, invitando i visitatori a esplorare i giardini con una guida e assaggiare i prodotti appena raccolti, preparati semplicemente in spuntini stagionali.
Anche se forse il miglior esempio di cucina dal campo alla tavola nella laguna si può trovare a Venissa. Sotto la guida di Chiara Pavan e Francesco Brutto, il ristorante stellato Green Michelin offre uno scorcio dell’ambiente lagunare—in particolare quello dell’Isola di Mazzorbo e dei giardini della tenuta—tradotto in piatti verdi, stimolanti e prevalentemente a base vegetale. Le proteine animali sono usate con parsimonia e spesso provengono da specie acquatiche invasive che si sono diffuse nella laguna. Invitando i commensali ad agire come predatori simbolici di queste specie non native, e presentandole in modi inaspettatamente deliziosi e innovativi, Pavan e Brutto stanno ridefinendo la percezione della cucina veneziana contemporanea.
Sono stati tra i primi nella zona, ad esempio, a servire il granchio blu invasivo e vorace. Uno dei pescatori che rifornisce il loro ristorante ha iniziato a portarli a secchiate, avendoli trovati impigliati nelle reti destinate ai granchi verdi più piccoli—moeche. Pavan e Brutto hanno iniziato ad acquistare il granchio blu e a metterlo in menu, e dopo questo esperimento iniziale, hanno esteso l’approccio ad altri bivalvi e pesci non nativi. Hanno anche notato che la tenuta era sempre più popolata da alofite—erbe e piante tolleranti al sale come la salicornia e la porcellana di mare—a causa dell’aumento dei livelli di salinità nel terreno dell’isola. Anche queste sono diventate parte integrante dei loro esperimenti di “cucina ambientale”, dando un croccante naturalmente salino ai loro piatti—come il loro raviolo con salsa di pesce, finocchio marino tritato, uvetta ed erbe alofite, per citarne solo uno.

Le alofite sono centrali in molti progetti contemporanei e un focus crescente degli chef che lavorano con la cucina legata al terroir. Forse l’iniziativa più notevole è guidata dall’agenzia di ricerca The Tidal Garden, che dal 2020 esplora il potenziale commestibile delle alofite come strumento di adattamento culturale al cambiamento climatico. Promosso da prometheus_open food in collaborazione con agricoltori locali nell’area di Cavallino-Treporti nella laguna nord, il progetto cerca di sviluppare una strategia di adattamento comunitario per i suoli sempre più salmastri della regione e di fronte al cambiamento climatico. Molte specie di alofite sono endemiche della laguna e storicamente hanno contribuito alla prosperità—più nella produzione del vetro che in cucina—di Venezia e delle città circostanti prima di svanire dalla cultura locale. Ora prosperano nelle paludi salmastre e nei terreni agricoli in espansione, queste piante tolleranti al sale offrono il potenziale per ridefinire le pratiche agricole e alimentari nella Laguna di Venezia in nuove condizioni di marea.
L’ambito culinario offre abbondanti opportunità di cross-pollination, servendo come uno dei modi più tangibili per sperimentare e riflettere sui cambiamenti che la laguna sta subendo. Gli eventi comunitari organizzati dagli stessi Tocia! o The Tidal Garden spesso intrecciano conversazione, contemplazione e coinvolgimento sensoriale—come è successo in occasione della serie Convivial Tables di TBA21–Academy, che ha inquadrato la tavola da pranzo come “l’avenue perfetto per discutere i legami complessi tra ciò che mangiamo e il suo impatto ecologico, con un focus particolare sul suo effetto sui corpi idrici.”
Quando si tratta di Venezia e sostenibilità, quindi, sembra che non ci sia pietra lasciata non rivoltata, nessun campo inesplorato. All’incrocio tra ecologia, cucina, arte, letteratura, attivismo, urbanistica e architettura, la conversazione è viva, in corso, critica e stimolante—non proprio al punto di chiedere, “La lasciamo affondare?” come scherzava il mio amico—piuttosto, sollevando costantemente domande su come plasmare il futuro della città e della sua laguna in un modo che sembri meno una lotta e più una confluenza di intenti.