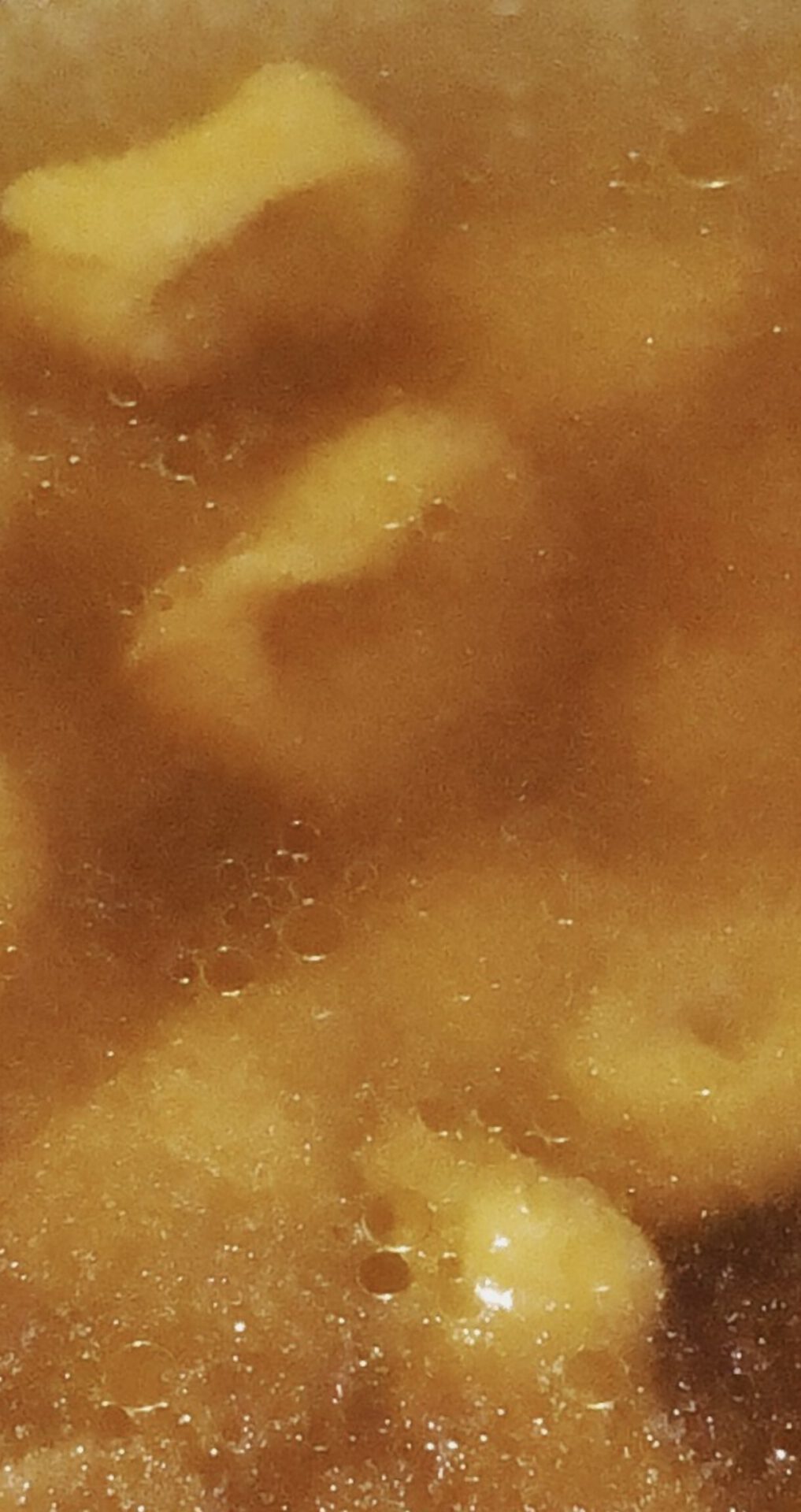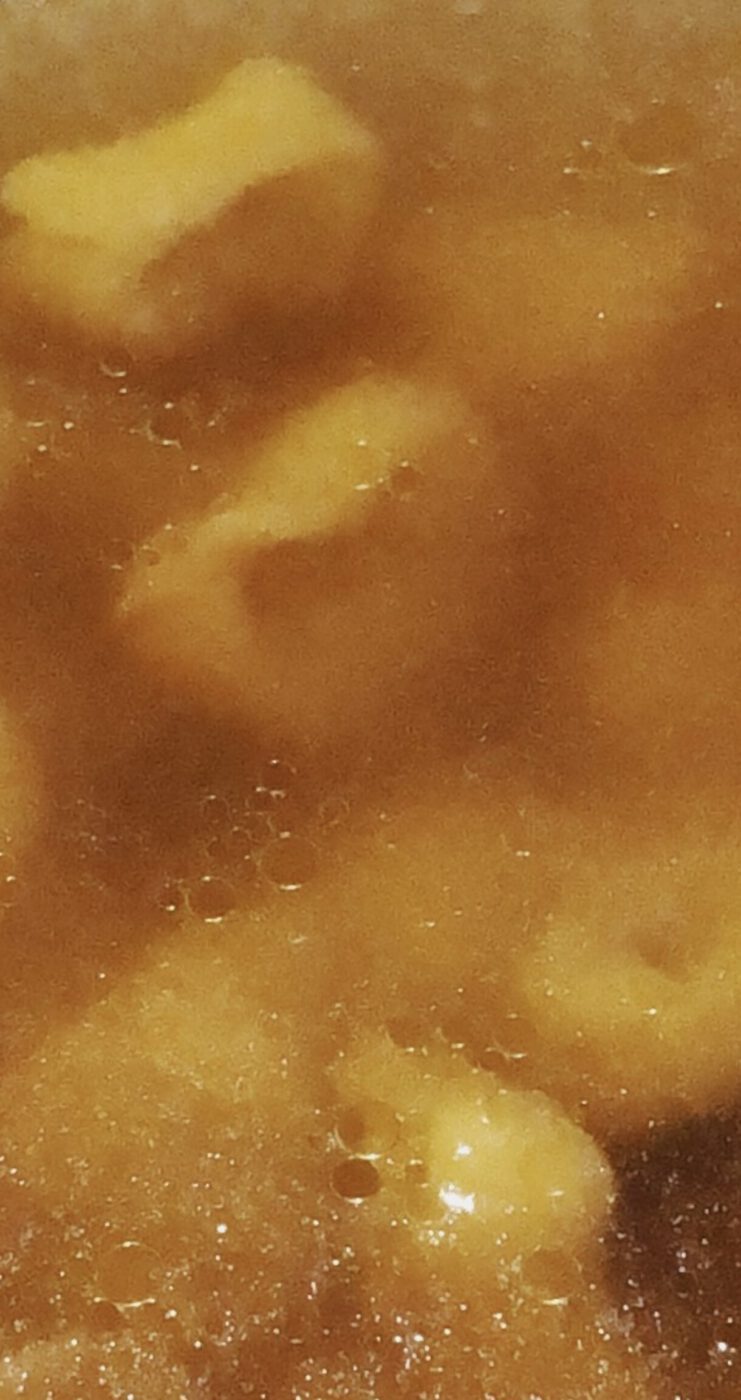Ho sempre avuto un rapporto ambivalente con il concetto di caratteri nazionali e regionali; l’idea che le persone sviluppino caratteristiche culturali specifiche e comportamenti entro i confini del loro paese o regione di provenienza mi sembrava antiquata e pericolosamente vicina a derive ideologiche.
Essere italiano ha posto alcune sfide a questo approccio. In una nazione grande circa un trentesimo degli Stati Uniti, si parlano attualmente circa 34 lingue e dialetti correlati.
Il fatto che ciascuna delle venti regioni del paese creda di essere migliore delle altre non ha mai davvero aiutato la nostra unità nazionale. Abbiamo persino una parola per questo: ” campanilismo” (liberamente traducibile in “parochialismo”) deriva da questa eterna rivalità, che a sua volta origina da faide primordiali tra villaggi.
Si potrebbe persino sostenere che l’identità stessa della nazione sia fatta di differenze regionali, che io tendevo a ignorare severamente. Fino a quando ho incontrato mio marito.

“Se chiedi da bere e ti offrono acqua, sei ancora in Emilia. Se invece ti offrono vino, sei arrivato in Romagna”. Il vecchio detto è un utile promemoria per almeno un paio di pensieri… primo: anche se Emilia e Romagna fanno parte della stessa regione, sono separate e completamente diverse; e secondo: i romagnoli sono molto divertenti.
Quando ho incontrato Riccardo per la prima volta avevo 21 anni e non conoscevo molte persone della Romagna. Avevo formato un’idea romantica della regione dai viaggi passati durante la mia infanzia e guardando i film di Federico Fellini. Questo era tutto.
Più lo conoscevo nella sua città natale, Forlì, più diventava chiaro che avevamo caratteri totalmente opposti che riflettevano stereotipi culturali. Io, la piemontese: introversa, tranquilla e irrimediabilmente formale; e lui, il romagnolo, socievole, chiassoso e spontaneo.
La prima cosa che mi ha colpito è che Riccardo parla, e parla, e parla. Tanto.
Anche se vive all’estero da un po’ di tempo, ha mantenuto un accento piuttosto forte e adorabile di cui inevitabilmente mi prendo gioco. L’espressione più chiara di questo è l’assibilazione della lettera “z”, il che significa che pronuncia ogni “z” come fosse una “s”. Ancora oggi lo prendo in giro ogni tanto, facendogli dire: “un pezzo di pizza”.
Quando la nostra relazione ha iniziato a diventare seria, la mia introduzione ai suoi genitori è diventata inevitabile. Si è scoperto che, rispetto al resto della sua famiglia, Riccardo aveva mantenuto solo una frazione del suo carattere regionale. Il vero shock culturale doveva ancora arrivare; la famiglia di Riccardo è enorme (costituivano metà degli invitati al ricevimento del nostro matrimonio, per essere precisi), rumorosa e ovunque.
Per fortuna, mi sono innamorata di un uomo proveniente da una terra famosa per l’allegria, l’ospitalità e la mentalità aperta della sua gente. Mi hanno accolto a braccia aperte. E se all’inizio cercavano di contenersi per adattarsi ai miei sobri standard nordici, questo è cambiato abbastanza rapidamente. Di conseguenza, ho iniziato anch’io a rilassarmi, abbracciando lo stile di vita romagnolo.
La mia iniziazione includeva giornate estive sulla riviera di Rimini circondata da decine di bambini urlanti; infinite gite in moto (l’amore dei romagnoli per praticamente qualsiasi cosa su ruote è un pilastro della cultura locale); pranzi domenicali in famiglia che invariabilmente si trasformano in intensi dibattiti politici. Mia suocera mi ha fatto scoprire la Biblioteca Malatestiana del XV secolo a Cesena e i laboratori di ceramica a Faenza. Io, a mia volta, l’ho trascinata a visitare ogni singola chiesa di Ravenna.
Il cibo, ovviamente, ha sempre avuto un ruolo importante nel mio matrimonio.
Come introduzione alla gastronomia locale, mi è stata data una copia del libro di cucina di Pellegrino Artusi La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene (Science in the Kitchen and the Art of Eating Well), pubblicato per la prima volta nel 1891. Anche se ho quasi apprezzato l’italiano antiquato dei testi più delle ricette in esso contenute, prometto che ne ho seguite alcune.
Ho deciso di iniziare con qualcosa di facile. Mi ci è voluto un giorno intero per fare il brodo di pollo di Artusi (e tutto il giorno prima per procurarmi tutti gli ingredienti elencati), ma alla fine sono riuscito a fare il miglior brodo di sempre.
Ho anche riscoperto la gioia della piadina, e sono stato introdotto ad altre specialità come lo squacquerone con fichi caramellati; il budino di castagne di mio suocero – fatto seguendo rigorosamente una ricetta di famiglia vecchia di più di un secolo; la leggendaria crostata di zia Laura; e, ovviamente, un classico invernale: i cappelletti in brodo.

Di solito io e Riccardo passiamo il giorno di Natale a San Francisco, ospitando il pranzo per i nostri amici. Quando un paio di anni fa la nostra fidata salumeria italiana per la pasta fresca ha chiuso, abbiamo cercato valide alternative, con scarsi risultati. Dopo aver provato un posto che faceva cappelletti grandi come palline da golf, Riccardo ha tirato fuori il suo lato romagnolo e ha deciso di farli da zero. Ha chiamato sua nonna per consigli, ha comprato una macchina per la pasta e mi ha coinvolto ad aiutarlo. Ovviamente, quell’anno aveva invitato una trentina di persone. Quindi, come prova suprema d’amore, ho passato l’intera vigilia di Natale e la mattina di Natale a fare cappelletti, che devo dire sono venuti piuttosto bene. Sapevo già come fare il brodo perfetto per accompagnarli.
Ricetta n. 7 di Pellegrino Artusi
Cappelletti all’uso di Romagna
Si chiamano così per la loro forma a cappello. Ecco il modo più semplice per farli in modo che siano meno pesanti sullo stomaco:
– Ricotta, o metà ricotta e metà raviggiolo, grammi 180.
– Mezzo petto di cappone cotto nel burro, condito con sale e pepe, e tritato finemente.
– Parmigiano grattugiato, grammi 30.
– Uova grandi: uno intero e un tuorlo.
– Noce moscata, poche spezie, scorza di limone per chi la gradisce.
– Un pizzico di sale.
Assaggia l’impasto così da poterlo correggere se necessario perché gli ingredienti non sempre si accordano allo stesso modo. Se il petto di cappone non è disponibile, aggiungi 100 grammi di lonza di maiale, cotta e condita allo stesso modo.
Se la ricotta o il raviggiolo è troppo morbido, ometti l’albume. Se l’impasto è troppo sodo, aggiungi un altro tuorlo. Per sigillare la pasta, fai un impasto abbastanza tenero solo con farina, acqua e uova, usando parte dell’albume rimasto. Taglialo con un disco rotondo. Metti l’impasto al centro dei dischi e piegali a metà, formando una mezzaluna; poi prendi le due estremità e uniscile per formare il cappelletto finito.
Se il foglio di pasta si asciuga in mano, immergi il dito nell’acqua e bagna i bordi dei dischi. Il brodo dev’essere quello di cappone per dargli quel sapore così gratificante. La bontà di questo sciocco animale viene offerta nella solennità del Natale.
Quindi, cuoci i cappelletti nel suo brodo come si fa in Romagna, dove troverai quegli eroi che si vantano di averne mangiati un centinaio in un solo giorno. C’è il caso possibile però di morte, come è successo a un mio conoscente. Un mangiatore modesto non ha bisogno di più di due dozzine.